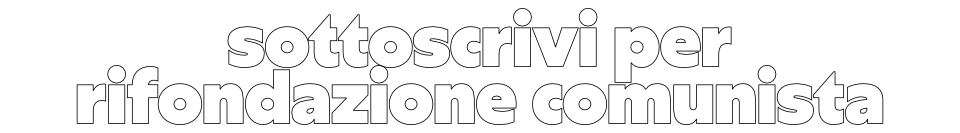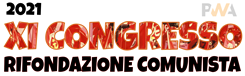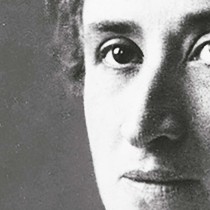
“Come una candela che brucia da due parti”
Pubblicato il 4 mar 2019
Dino Greco
I fili da tirare, nel pensiero e nell’azione di questa straordinaria rivoluzionaria (entrambi i termini, per una volta, non sono abusati) sono molti e ci consegnano un materiale su cui riflettere, oggi più di ieri, quando la storia ha consumato, nel fuoco di brucianti sconfitte, la speranza di una radicale trasformazione dei rapporti sociali, oggi come ieri segnati col marchio dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Io insisterò solo su alcuni aspetti che mi paiono ancora oggi e persino più di ieri densi di significato e di insegnamenti.
Alla fine dell’Ottocento è in pieno svolgimento uno scontro aperto nella socialdemocrazia tedesca sulle prospettive della rivoluzione. Uno scontro destinato a segnare, nel suo epilogo drammatico, la deriva che passo dopo passo coinvolgerà tutte le socialdemocrazie europee: il divorzio dal marxismo e l’approdo, in forme via via più esplicite, alla cultura liberale.
Dopo la morte di Marx e di Engels (e secondo Luxemburg anche con qualche complicità di quest’ultimo) sta prevalendo nel marxismo degli epigoni, nella Seconda internazionale, un’idea meccanicistica, positivistica, evoluzionistica della rivoluzione. Si tratta dell’idea – che non fu mai di Marx – secondo cui lo sviluppo del capitalismo, la crescita delle forze produttive generate dal capitalismo al più alto livello del suo sviluppo, avrebbe portato necessariamente al socialismo, per cui compito del partito era semplicemente quello di accompagnare senza strappi questo processo verso il suo necessario sbocco.
Il tema della rivoluzione veniva dunque rimosso, seppure surrettiziamente, al di là della fraseologia classica che per un po’ ebbe ancora libero corso, per mascherare abiure e tradimenti.
Il marxismo assimilato dalla socialdemocrazia tedesca aveva perso gran parte del suo mordente dialettico e del suo vigore rivoluzionario, e a seconda delle circostanze o dei temperamenti personali esso veniva interpretato come messianismo rivoluzionario, come predicazione millenaristica, o come la teoria che giustificava la partecipazione alle elezioni e al lavoro pratico quotidiano, ripiegato però in un presente senza futuro.
Il programma approvato al congresso di Erfurt del 1891 aveva tentato di conciliare la duplice esigenza, ponendo, una accanto all’altra, una parte teorica contenente affermazioni rivoluzionarie e una parte pratica contenente un programma minimo d’azione, ma senza riuscire a realizzare un nesso effettivo fra i due momenti.
Con la conseguenza che il programma minimo non serviva affatto a preparare la crisi rivoluzionaria ma piuttosto ad attenderla, mentre la parte teorica non riusciva a definire una strategia proletaria e lasciava nel vago la conquista del potere.
Il risultato di questa incapacità di saldare le due fasi fu che mentre il partito si dedicava sempre più intensamente all’attività pratica quotidiana, la prospettiva rivoluzionaria appariva sempre più campata per aria e astratta dalla realtà.
Per Rosa Luxemburg, invece, esiste una differenza di «essenza», non di «durata», tra riforma legale e rivoluzione. Esse corrispondono a opzioni, rapporti di forza, impostazioni di fondo completamente differenti, per cui è sbagliato identificare la riforma con «una rivoluzione tirata per le lunghe» o la rivoluzione con una «riforma concentrata». La divergenza sui tempi della trasformazione sociale diventa, da subito, anche divergenza sulla natura di questa trasformazione: se, per farla breve, la trasformazione debba concludersi nell’abbattimento dell’apparato statale e produttivo oppure nel suo graduale cambiamento attraverso una programmata e costante politica riformista.
Karl Kautsky sarà l’autorevolissimo interprete di questa dottrina che lo porterà a criticare aspramente la rivoluzione d’Ottobre perché essa bruciava – a suo dire – le tappe necessarie della fase democratico-borghese e avveniva in un paese ancora profondamente segnato dal sottosviluppo dunque non pronto per il socialismo.
Sarà poi Eduard Bernstein a compiere lo strappo decisivo e a portare queste premesse teoriche sino alle loro estreme conseguenze.
Eravamo, in quel periodo, in una fase di grande sviluppo del capitalismo tedesco. La Germania, stava allora attraversando un momento di prosperità economica. Dal quarto posto che essa occupava fra i paesi industriali nel 1870, passava al terzo intorno al 1890 e al secondo intorno al 1900. Il volto economico del paese mutava rapidamente: il processo di concentrazione celebrava i suoi trionfi nell’industria del ferro, dell’acciaio e del carbone, nonché nella chimica e nell’elettrotecnica, ponendo le basi di una politica imperialistica che doveva estrinsecarsi nel commercio estero, nelle conquiste coloniali, nella politica internazionale, nella corsa al riarmo.
Agli occhi di Bernstein il capitalismo è ormai al riparo da un “crack economico generale”.
Il crollo del sistema è per lui è un’illusione romantica. Anzi, la transizione indolore verso una società che assorbe del tutto i conflitti di classe è secondo lui scritta nelle cose, quasi obbedendo ad una legge naturale: lo sviluppo del movimento cooperativo, dell’azionariato diffuso, l’estensione del credito, gli imprenditori che sono destinati a trasformarsi in semplici gestori e “amministratori” della loro proprietà, sono per Bernstein tutti segnali che il capitalismo genera da se stesso gli elementi che conducono alla sua autoregolazione.
La contraddizione di classe è del tutto cancellata.
Per Bernstein il capitalismo aveva trovato il modo di adattarsi alle necessità storiche, di liberarsi dalle crisi ricorrenti, e di assicurare la propria sopravvivenza eliminando a poco a poco le proprie difficoltà e i propri lati negativi.
Grazie allo sviluppo capitalistico le condizioni dei lavoratori avrebbero conseguito un graduale e sicuro miglioramento. Per cui la tattica più acconcia per consolidare questi risultati doveva essere quella di appoggiare l’espansione economica capitalistica. Bernstein arrivò a dichiararsi favorevole anche al colonialismo.
La conclusione inevitabile fu che bisognava tenere a freno, con ogni mezzo, le tendenze rivoluzionarie: il socialismo cessava di essere obiettivamente necessario.
I segretari delle organizzazioni di partito e i dirigenti sindacali, i consiglieri comunali e i deputati, i portatori del lavoro politico di ogni giorno, determinavano il carattere del partito, che “già prima del ‘900 – notava Luxemburg – si era mutato essenzialmente in un lavoro pratico con alcune frasi rivoluzionarie non prese sul serio”.
Fin dal 1892 si poteva in un certo senso parlare di una lotta di classe all’interno della socialdemocrazia stessa, con l’ingresso nel partito di elementi – è Rosa che parla- “senza nessun sentimento rivoluzionario e senza sensibilità proletaria, strati sociali che non solo non pensavano ad eliminare radicalmente ordinamento economico esistente, ma che miravano a procurarsi all’interno di esso una posizione migliore”.
Sicché mentre i dirigenti del partito continuavano ad usare la terminologia tradizionale e a pagare il dovuto tributo verbale al marxismo, il partito subiva in quegli anni una trasformazione profonda ed irreversibile.
Si arriverà così sino alla determinazione che in caso di guerra la socialdemocrazia avrebbe collaborato alla difesa del paese.
Era già in incubazione quella linea che porterà al progressivo cedimento della socialdemocrazia tedesca fino alla capitolazione dell’agosto del 1914, quando la socialdemocrazia voterà a favore dei crediti di guerra, resa che metterà sul fronte proletari contro proletari nella guerra imperialista e che segnerà la fine della Seconda Internazionale.
Contro quella che sarebbe in seguito diventata un’abiura radicale si scaglia Rosa Luxemburg, con impressionante efficacia polemica, sin dal suo saggio del 1899 “Riforma sociale o rivoluzione”.
E’ stato osservato che il valore essenziale di questo scritto è nel metodo, e il metodo è tuttora valido, anzi più importante oggi che la pratica dell’opportunismo, ipocritamente ribattezzato come “realismo politico” o anche “politica delle cose”, ha devastato pressoché tutto il movimento operaio occidentale o, per meglio dire, i suoi esangui epigoni.
Si badi: Rosa non era affatto contraria alla rappresentanza e alla lotta parlamentare quando non la si intendesse come
la via al socialismo. Il fatto è che la parlamentarizzazione dei partiti socialisti, intesa come via al socialismo, ha indubbiamente contribuito in modo notevole al trionfo dell’opportunismo: per conquistare seggi parlamentari occorre infatti estendere l’influenza del partito a strati più vasti di popolazione e ciò avviene troppo spesso non conquistando la coscienza di questi strati al socialismo ma adattando il socialismo alla mentalità e ai bisogni pratici di questi strati.
In ogni caso, la risposta più efficace, che Luxemburg anticipò, Bernstein l’avrebbe avuta dalla storia.
Accecato dalla prosperità di quegli anni, Bernstein aveva dichiarato che difficilmente vi sarebbero state ancora delle crisi economiche generali, e viceversa una nuova crisi arrivò subito agli inizi del secolo; aveva annunciato che i sindacati avrebbero gradualmente espropriato i profitti a favore dei salari e invece si ebbe l’impetuoso sviluppo dell’accumulazione capitalistica; aveva suggerito alla socialdemocrazia di trasformarsi in un partito democratico che stringesse alleanze con la borghesia rimasta sana per migliorare progressivamente il regime e le elezioni del 1903 gli diedero una pesante risposta; aveva pensato ad un mondo pacificato e invece si arrivò alla carneficina del primo conflitto mondiale fra imperialismi.
Se Rosa fosse vissuta più a lungo avrebbe potuto aggiungere a queste considerazioni le esperienze successive: un’altra guerra mondiale, la sconvolgente crisi economica del 1929 e degli anni successivi, infine la feroce dittatura nazista che hanno fatto definitiva giustizia di tutte le illusioni e di tutti gli ottimismi revisionistici, mostrando quanto profonde radici abbiano le contraddizioni capitalistiche, quanto instabile sia la prosperità, quanto insicura la democrazia, quanto incerto il progresso sociale sul fondamento dell’attuale formazione economico-sociale che ancora oggi domina le nostre vite.
Rosa Luxemburg non ha evitato l’accusa di “crollismo”, vale a dire l’accusa di essere rimasta prigioniera dell’idea che il capitalismo sarebbe giunto ad un inevitabile collasso in ragione delle sue interne contraddizioni.
Qui bisogna chiarire. In Luxemburg non c’è nessuna attesa messianica del socialismo.
In una delle sue opere più importanti, “L’accumulazione del capitale ”, del 1913, un’opera molto discussa e in parte contestata dallo stesso Lenin, Luxemburg sostiene che l’espansione del capitalismo non rende il mondo omogeneo, ma costruisce costantemente una gerarchia di “centri” e “periferie” funzionale all’accumulazione. L’asimmetria non riguarda soltanto la divisione tra settore primario e secondario – per altro tutt’oggi assai rilevante – ma anche quella tra settori manifatturieri obsoleti ad alta intensità di lavoro e settori avanzati ad alta intensità di capitale.
Luxemburg scrive:
“Con quanta maggior potenza il capitale, grazie al militarismo, fa piazza pulita, in patria e all’estero, degli strati non capitalistici e deprime il livello di vita di tutti i ceti che lavorano, tanto più la storia quotidiana dell’accumulazione del capitale sulla scena del mondo si tramuta in una catena continua di catastrofi e convulsioni politiche e sociali, che, insieme con le periodiche catastrofi economiche rappresentate dalle crisi, rendono impossibile la continuazione dell’accumulazione e necessaria la rivolta della classe operaia internazionale al dominio del capitale, prima ancora che, sul terreno economico, esso sia andato ad urtare contro le barriere naturali elevate dal suo stesso sviluppo”.
Rosa Luxemburg è convinta che, una volta assimilato e trasformato in senso capitalistico anche l’ambiente non capitalistico, il capitalismo incontrerà difficoltà insormontabili nel processo di accumulazione.
Ma – aggiunge – “il capitalismo non si toglierà di mezzo da solo”: diventerà sempre più feroce e distruttivo. Compiuta la conquista violenta del mondo non capitalistico, subentrerà la “lotta di concorrenza fra i capitali su scala mondiale per l’accaparramento delle residue possibilità di accumulazione” e le potenze capitalistiche si volgeranno le une contro le altre in una escalation di violenza capace di travolgere l’intera umanità.
Rosa Luxemburg, non dimentichiamolo, conclude la sua opera alla vigilia della conflagrazione della prima guerra mondiale.
Per questo – ammonisce – è “necessaria la rivolta della classe operaia internazionale”. Perché a quel punto si porrà di fronte all’umanità un dilemma davvero epocale, che Rosa definirà, con eccezionale lucidità e preveggenza: “O socialismo o barbarie”.
Facciamola parlare, Rosa Luxemburg.
Nelle “Tesi sui compiti della socialdemocrazia internazionale” del 1915, Luxemburg affermerà che “la guerra mondiale ha annientato i risultati di quarant’anni di lavoro del socialismo europeo, avendo distrutto l’importanza della classe operaia rivoluzionaria e il prestigio morale del socialismo, mandata in pezzi l’internazionale proletaria, condotte le sue sezioni al reciproco fratricidio e incatenato alla barca dell’imperialismo desideri e speranze delle masse popolari dei più importanti paesi del sistema capitalistico”.
“Con l’approvazione dei crediti di guerra e la proclamazione della pace civile i capi ufficiali dei partiti socialisti di Germania, Francia e Inghilterra hanno assicurato le spalle all’imperialismo, hanno indotto le masse popolari alla paziente sopportazione della miseria e degli orrori della guerra e hanno così contribuito allo scatenamento sfrenato del delirio imperialista, al prolungamento della carneficina e alla moltiplicazione delle sue vittime, hanno condivisa la responsabilità della guerra e delle sue conseguenze”.
E ancora:
“Codesta tattica delle istanze ufficiali di partito dei paesi belligeranti, in primissima linea in Germania, il paese fino ad oggi guida dell’Internazionale, rappresenta un tradimento ai principi più elementari del socialismo internazionale. Sacrificando la lotta di classe in tempo di guerra e procrastinandola al dopoguerra, la socialdemocrazia ufficiale delle grandi potenze ha dato tempo alle classi dominanti di rafforzarsi enormemente a spese del proletariato sul piano economico, politico e morale”.
“La guerra mondiale non serve né alla difesa nazionale né agli interessi economia e politici di alcun popolo: è esclusivamente un parto delle rivalità imperialistiche tra le classi capitalistiche di vari paesi per il predominio mondiale e il monopolio dello sfruttamento e dell’oppressione dei territori non ancora dominati dal capitale”.
“Nell’era dell’imperialismo scatenato non c’è più posto per guerre nazionali. Gli interessi nazionali servono solo di pretesto per porre le masse lavoratrici al servizio del loro mortale nemico, l’imperialismo”.
“In queste circostanze l’attuale guerra mondiale rappresenta, a parte chi vinca o perda, una sconfitta del socialismo e della democrazia. Qualunque suo esito – che non sia l’intervento del proletariato internazionale – non evita il rafforzamento del militarismo, dei contrasti internazionali, delle rivalità economiche. Essa accentua lo sfruttamento capitalistico e la reazione in politica interna, indebolisce il controllo pubblico e abbassa i parlamenti a strumenti sempre più passivi del militarismo. L’attuale guerra mondiale sviluppa così nello stesso tempo tutti i presupposti di nuove guerre”.
Rosa Luxemburg e Karl Liebnecht si opporranno sino all’ultimo alla degenerazione della socialdemocrazia tedesca, al governo di Ebert e Scheideman.
Rosa li battezzerà come i “peggiori e più infami furfanti che abbiano vissuto al mondo”.
Il primo gennaio del 1919 Rosa Luxemburg e Karl Liebnecht trasformeranno la Lega di Spartaco nel Partito comunista di Germania di cui Rosa scrisse il programma, pur ritenendo prematuro quest’atto e a maggior ragione la dichiarazione di insurrezione decisa nella notte del 6 gennaio dal Comitato rivoluzionario, con alla testa Karl Liebnecht.
Rosa aveva scritto in passato:
«La Lega Spartaco non prenderà mai il potere altrimenti che sulla base della volontà chiara e univoca della grande maggioranza della massa proletaria della Germania, e non agirà che sulla base del cosciente consenso di questa con le idee, gli obiettivi e i metodi della Lega Spartaco».
Ma la maggioranza del neocostituito partito cade nella trappola dei suoi avversari e forza gli avvenimenti con un’insurrezione che si sarebbe risolta in un disastro.
Contro l’insurrezione si scatena la repressione, violentissima, del governo socialdemocratico e dei Freikorps, le squadre paramilitari di Gustav Noske che su ordine del governo arrestano Rosa Luxemburg, la massacrano di botte durante il percorso verso il carcere e la gettano in un canale.
Anche Karl Liebnecht, Franz Mehring (autore di quella che rimane la più bella biografia di Karl Marx), Leo Jogiches (per tanti anni compagno di vita di Rosa), tutti fondatori della Lega spartachista, conobbero la stessa sorte.
Il programma del neonato partito comunista di Germania, a 15 giorni dall’assassinio di Rosa, lo rende quasi un testamento. Scriverà, a conclusione del suo intervento:
“Viviamo oggi il momento in cui possiamo dire: siamo di nuovo con Marx, sotto la sua bandiera. Se oggi noi dichiariamo nel nostro programma: il compito immediato del proletariato non è altro, riassunto in poche parole, che fare del socialismo verità e realtà e sradicare completamente il capitalismo, noi ci mettiamo sul terreno in cui stavano Marx ed Engels nel 1848 e dal quale essi non si scostarono mai in linea di principio. Adesso si vede che cos’è il marxismo vero e che cosa era questo surrogato”.
L’ultimo messaggio di Rosa, il suo commiato, risale al 15 gennaio, esattamente il giorno del suo assassinio:
“La direzione è mancata. Ma essa può e deve essere creata a nuovo dalle masse e tra le masse. Le masse sono il fattore decisivo, sono la roccia sulla quale sarà edificata la vittoria finale della rivoluzione. Le masse sono state all’altezza della situazione, esse hanno fatto di questa sconfitta un anello di quelle sconfitte storiche che sono l’orgoglio e la forza del socialismo internazionale. E perciò da questa sconfitta sboccerà la futura vittoria.
“L’ordine regna a Berlino!” Stupidi sbirri! Il vostro ordine è costruito sulla sabbia. La rivoluzione già da domani “di nuovo si rizzerà in alto con fracasso” e a vostro terrore annuncerà con clangore di trombe: “Io ero, io sono, io sarò”.
Ho lasciato per ultimo il nodo che, a mio giudizio, rappresenta il “nocciolo duro” del pensiero luxemburghiano, vale a dire il rapporto fra partito e masse, fra organizzazione e spontaneismo, fra azione rivoluzionaria e democrazia proletaria.
Questioni che non sono il risultato di una disputa astratta ma si sviluppano nel fuoco del processo della lotta di classe rivoluzionaria e hanno per epicentro la rivoluzione sovietica e chiamano direttamente in causa la discussione senza veli e reticenze che si svolge fra Luxemburg e il gruppo dirigente bolscevico che sta facendo nella realtà, non in vitro, la prima rivoluzione proletaria della storia mondiale.
L’entusiasmo di Rosa per ciò che sta accadendo in Russia è enorme, come la stima assoluta che essa non lesinò mai nei confronti del pugno di uomini e di donne che sta provando a mutare il corso della storia mondiale.
Anzi, Rosa attaccherà a fondo la socialdemocrazia tedesca e il suo eccelso teorico, Karl Kautsky, depositario ufficiale del pensiero marxista dopo la morte di Marx e di Engels, che criticò duramente l’accelerazione imposta dai bolscevichi, ritenendo che non si potesse annullare la fase della democrazia borghese.
“In realtà – scrive Rosa – l’unica via di uscita per liberare la rivoluzione dall’impasse era quella del “partito di Lenin”: “tutto il potere nelle mani esclusive delle masse operaie e contadine, nelle mani dei soviet”.
È questa “la legge vitale” delle grandi rivoluzioni, prosegue Luxemburg, citando gli esempi della rivoluzione inglese e di quella francese: o avanzare con decisione, con la spinta degli elementi più radicali (i Levellers, i giacobini), oppure “essere schiacciati dalla controrivoluzione”.La “saggezza casareccia dell’infantilismo parlamentare” – commenta ancora, con particolare riferimento ai socialdemocratici tedeschi – per cui occorre prima conquistare la maggioranza, va rovesciata: “la strada non porta alla tattica rivoluzionaria attraverso la maggioranza, ma alla maggioranza attraverso la tattica rivoluzionaria”. Con il socialismo come meta finale.
Tuttavia, già diversi anni prima, in polemica con Lenin, Luxemburg aveva sostenuto che, se si vuole difendere il movimento operaio dalle “mene opportunistiche dei suoi intellettuali ambiziosi”, il rimedio di chiuderlo “nella corazza di un centralismo burocratico”, di ridurlo “a docile strumento di un ‘comitato’”, è controproducente. La “garanzia più sicura” è invece “l’autonoma attiva partecipazione dei lavoratori, il rafforzamento del loro senso di responsabilità politica”.
Ora, sugli effetti nefasti di un centralismo burocratico corazzato non ci sono dubbi. Il problema è la fiducia incondizionata – talvolta dal sapore messianico – di Luxemburg nelle “masse”, nel loro costante intervento risolutorio. L’autonomia e la responsabilità delle masse, in realtà, vanno suscitate, difese e organizzate; ed è inevitabile il formarsi di un’élite, di un gruppo dirigente coeso e capace di dirigere con mano di ferro il processo rivoluzionario.
Secondo Lenin solo il partito organizzato può spostare in senso rivoluzionario le forze in campo, coinvolgendo masse che sono rivoluzionarie solo “istintivamente”, ma senza “chiara coscienza”.
Per dirla con le parole di Antonio Gramsci: “Sono i capitani che fanno l’esercito, non viceversa”. Anche se il partito deve tendere, anche e prima di tutto al suo interno, a superare la scissione fra governanti e governati, dirigenti e diretti.
Rosa solleva una critica molto dura agli sviluppi immediatamente successivi alla presa del potere e alla decisione dei bolscevichi di cancellare l’assemblea costituente, di accantonare tout court la questione della democrazia e di concentrare tutto il potere nelle mani del partito, con la sovrapposizione di esso ai soviet e agli organi dello Stato, non più tra loro distinguibili.
La critica è severissima:
la decisione di sospendere le libertà si risolve nell’«imbarbarimento della vita pubblica» e nella corruzione delle masse poiché «ogni prolungato regime di stato d’assedio conduce inevitabilmente all’arbitrio e ogni altro arbitrio agisce in senso deprivante sulla società»; l’emergenza spegne le energie vitali del proletariato riconsegnandolo, così, a quella situazione di alienazione per il cui superamento aveva lottato.
La nuova società socialista, allora, appare paralizzata, spaccata e divisa tra le masse ridotte all’inerzia demoralizzate e piegate dal «regno del terrore» e la «dittatura di un pugno di politici» raccolti nel partito.
Ed ecco la conclusione, lapidaria:
“Col soffocamento della vita politica in tutto il paese, anche la vita dei soviet non potrà sfuggire a una paralisi sempre più estesa. Senza elezioni generali, libertà di stampa e di riunione illimitata, libera lotta d’opinione in ogni pubblica istituzione, la vita si spegne, diventa apparente ed in essa l’unico elemento attivo rimane la burocrazia. La vita pubblica si addormenta e poco per volta alcune dozzine di capi partito di inesauribile energia e animati da un idealismo sconfinato dirigono e governano; tra questi la guida effettiva è poi in mano a una dozzina di teste superiori e una élite di operai viene di tempo in tempo convocata per battere le mani ai discorsi dei capi, votare unanimemente soluzioni prefabbricate….non la dittatura del proletariato”.
“Lenin e Trockij – continua Luxemburg – sostengono che lo stato borghese è uno strumento di oppressione della classe operaia, mentre quello socialista di oppressione della borghesia. Esso non sarebbe perciò che lo stato capitalista capovolto. Ma questa concezione semplificata non prende in considerazione l’aspetto più importante, e cioè che il dominio di classe borghese non ha alcun bisogno di educare politicamente ed istruire la massa del popolo, per lo meno non oltre certi ristretti confini, mentre per la dittatura proletaria è l’elemento vitale, l’aria senza la quale non può sussistere. Tutta la massa del popolo deve prendervi parte”.
Secondo Luxemburg, l’errore fondamentale della teoria leninista-trockista è appunto quello di contrapporre la dittatura alla democrazia.
Per Rosa, il proletariato deve porre certo e immediatamente mano a misure socialiste nella maniera più energica, inflessibile e spietata, esercitare dunque la dittatura, ma una dittatura di classe, non di partito.
Scriverà:
“Non siamo mai stati fanatici della democrazia formale, ciò significa solo che abbiamo sempre distinto il nocciolo sociale dalla forma politica della democrazia borghese, che abbiamo sempre svelato l’amaro nocciolo della diseguaglianza e della servitù sociale sotto la dolce scorza dell’uguaglianza sociale e della libertà, non per rigettarle, ma per spronare la classe lavoratrice a non accontentarsi della buccia, quanto piuttosto a conquistare il potere politico per riempirlo di un nuovo contenuto sociale.
Quindi la stoccata decisiva:
“È compito storico del proletariato una volta giunto al potere, di creare la democrazia socialista al posto di quella borghese, non di abolire ogni democrazia”.
La democrazia socialista inizia con la
demolizione del dominio di classe e in pari tempo con la costruzione del socialismo.
Poi aggiungerà:
“Tutto ciò che succede in Russia è comprensibile, altro non è che una catena inevitabile di cause ed effetti il cui punto di partenza e la cui chiave di volta è il fallimento del proletariato tedesco. Sarebbe pretendere il sovraumano da Lenin e Trockij, se per giunta ci aspettassimo che in simili circostanze fossero in grado di creare come per incanto la più bella democrazia, la più esemplare dittatura del proletario ed una fiorente economia socialista. Con il loro risoluto atteggiamento rivoluzionario, con il loro attivismo esemplare e la loro incrollabile fedeltà al socialismo internazionale hanno certamente fatto quanto in una situazione così diabolicamente difficile era da fare (…).
I bolscevichi hanno dimostrato che possono far tutto ciò che un autentico partito rivoluzionario è in grado di portare a compimento nei limiti delle possibilità storiche. Non devono voler fare dei miracoli”.
“Ciò che conta è distinguere nella politica dei bolscevichi l’essenziale dall’inessenziale, il nocciolo dalle escrescenze fortuite”.
In questo senso, Lenin e Trockij unitamente ai loro compagni sono stati i primi a dar l’esempio al proletariato mondiale, e sono tuttora gli unici che possano esclamare: Io ho osato!”.
“Questa è l’essenza e questo è quanto resta della politica dei bolscevichi. In tal senso a loro rimane l’imperituro merito storico sia di essersi posti alla testa del proletariato internazionale conquistando il potere politico e ponendo il problema pratico della realizzazione del socialismo, sia di aver fatto progredire in modo poderoso la contrapposizione tra capitale e lavoro in tutto il mondo”.
“Il primo esperimento nella storia del mondo di dittatura della classe operaia [è stato attuato] nelle più difficili condizioni concepibili [...], [le quali] fanno comprendere come [...] anche il più gigantesco idealismo e la più incrollabile energia rivoluzionaria non siano stati in grado di realizzare né democrazia né socialismo, ma solo dei primi rudimenti impotenti e deformati di entrambi.
In Russia il problema ha solo potuto essere posto. Non vi poteva essere risolto. La soluzione risiede solo a livello internazionale. E in questo senso, l’avvenire appartiene dovunque al bolscevismo”.
Merita a questo punto sottolineare che tutti gli iscritti dell’ultimo Lenin, nella sua dura polemica con Stalin, recuperino ampiamente queste critiche di Rosa Luxemburg e divengano per lui una vera e propria ossessione.
Lenin constata il divario tra la grandezza dei compiti posti e la miseria, non solo materiale, ma anche culturale: l’apparato statale, dopo la scossa dei primi mesi successivi all’Ottobre, era rimasto sostanzialmente quello ereditato dal passato, vecchio – dirà Lenin – “fino all’impossibile, fino all’indecenza,”, pessimo, burocratico, “appena unto di olio sovietico”.
Nello Scritto sulla cooperazione l’impostazione di Lenin diviene assai diversa dal passato.
Quella stessa cooperazione che i bolscevichi avevano sempre ritenuto una manifestazione di semplice riformismo borghese gli appare nelle nuove condizioni come la via maestra per muovere verso il socialismo in Russia, specie nei villaggi.
Lenin pensa ad un movimento cui “partecipassero effettivamente le vere masse”: partecipassero “in modo attivo e non passivo”.
In tale luce si intuisce meglio il senso della più inattesa fra le ultime proposte di Lenin, tendente ad avviare una completa riforma dell’apparato statale.
La riforma doveva poi riflettersi anche nel partito: la proposta di allargare il comitato centrale sino a 50 e persino 100 membri con l’inclusione di operai, ma non di coloro che avevano già effettuato “un lungo servizio nei soviet”, cioè che erano passati da tempo a funzioni di governo.
Lenin si preoccupava cioè di combattere la burocrazia oltre che negli apparati statali anche in quelli di partito, là dove si manifestava.
Non solo. Alla futura commissione di controllo egli voleva fornire il diritto di sindacare la stessa attività del Politbjuro, in modo che nessun dirigente, “né il segretario generale, né alcun altro membro del comitato centrale” potesse impedirle di essere informata di tutto e di verificarne con scrupolo il funzionamento.
Lenin era sempre più preoccupato per la struttura centrale del potere e per i limiti degli stessi uomini che lo esercitavano.
E’ noto come il secondo colpo apoplettico mise Lenin fuori gioco. Per quest’ultima battaglia, gli mancarono il tempo e le forze.
In quei giorni egli scrisse quella “lettera al congresso” che poi è divenuta celebre come il suo “testamento”, nel quale non risparmiava giudizi severi su ciascuno dei principali dirigenti del partito.
Due cose vengono da Lenin indicate come irrinunciabili: l’alleanza con i contadini e l’unità del partito, entrambe minacciate.
Lo scontro che seguirà nel Pcus, la lotta fratricida, culminata con epurazioni divenute via via più drammatiche dirà quanto preveggente era stato l’ammonimento severo di Rosa Luxemburg.
Anni dopo, quando la diaspora nel gruppo dirigente bolscevico divenne autodistruttiva e il potere assunse forme sempre più cesaristiche, sarà Gramsci, nel 1926, ad indirizzare al partito comunista dell’Urss questa drammatica lettera:
“Compagni, voi siete stati, in questi nove anni di storia mondiale, l’elemento organizzatore e propulsore delle forze rivoluzionarie di tutti i paesi: la funzione che voi avete svolto non ha precedenti in tutta la storia del genere umano che la eguagli in ampiezza e profondità. Ma voi oggi state distruggendo l’opera vostra. Voi degradate e correte il rischio di annullare la funzione dirigente che il partito comunista dell’Urss aveva conquistato per l’impulso di Lenin; ci pare che la passione violenta per le questioni russe vi faccia perdere di vista gli aspetti internazionali delle questioni russe stesse, vi faccia dimenticare che i vostri doveri di militanti russi possono e devono essere adempiuti solo nel quadro degli interessi del proletariato mondiale”.
Questo aveva visto Rosa Luxemburg, con il suo sguardo presbite.
Così scrisse Lenin, alla morte di lei:
“Accade a volte alle aquile di scendere più in basso delle galline, ma mai alle galline di salire al livello delle aquile. Rosa Luxemburg si è sbagliata sulla questione dell’indipendenza della Polonia; si è sbagliata nel 1903 nella sua valutazione del menscevismo; si è sbagliata nella sua teoria sull’accumulazione del capitale…si è sbagliata nei suoi scritti dalla prigione nel 1918 (per altro, essa stessa, dopo essere uscita dalla prigione, alla fine del 1918 e all’inizio del 1919, ha corretto una gran parte dei suoi errori). Ma, malgrado i suoi errori Rosa è stata e rimane un’aquila; e non soltanto il suo ricordo sarà sempre prezioso per i comunisti del mondo intero, ma anche la sua biografia e le sue opere complete… costituiranno una lezione utilissima per l’educazione di numerose generazioni di comunisti del mondo intero”.
E così ha scritto di lei, magistralmente, Edoarda Masi:
“Rosa sta dalla parte delle masse perché sono oppresse, e la funzione educatrice delle élite è per lei finalizzata alla loro rivolta, alla rivoluzione – non al potere delle stesse élites per conto delle masse, vicario del potere borghese e a esso speculare. È una visione fino a oggi priva di sbocco politico, ma la sola dove la rivoluzione non sia destinata a divorare se stessa”.
“Se la talpa della storia è la verità che, celata al presente, si rivelerà nelle mutate condizioni del futuro, è in questo nostro tempo che si rovescia in rivincita tutto quanto era parso il risvolto negativo delle idee di Rosa e della sua sorte: puntare sulle masse – quando la rivoluzione
d’ottobre, la sola vittoriosa, aveva seguito altra via; optare per la pace – quando la socialdemocrazia aveva scelto la guerra, e la guerra era venuta, seguita poi ancora da un’altra ancora più tremenda e universale; trovarsi dalla parte degli sconfitti – il peggiore dei torti secondo la ragion politica.
Le vittorie di allora, se pure autentiche, non ci riguardano ormai, quando tutto è mutato e trascinato via dal tempo [...] Attuali e invincibili restano le idee degli sconfitti, perché rispondono ad un’esigenza insopprimibile degli esseri umani di questo tempo e ne rappresentano la nobiltà. Indipendentemente da se e fino a quando siano attuabili”.
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti