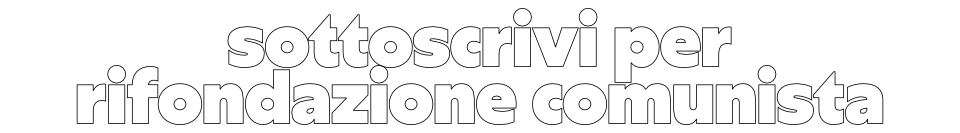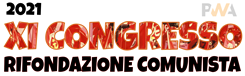Nuovo Cinema Franceschini
Pubblicato il 2 mar 2016
di Stefania Brai
Quello che va onestamente riconosciuto a questo governo è la coerenza. Da quando si è insediato non ha fatto che lavorare con assiduità e tenacia alla “rottamazione” dei diritti, dello stato sociale e delle forme democratiche di partecipazione. Lo ha fatto con la Costituzione, con il lavoro, lo sta facendo con la sanità pubblica, lo ha fatto e lo sta facendo con la conoscenza e la cultura: con la scuola, finalizzandola al mercato del lavoro; con il servizio pubblico radiotelevisivo, tentando di trasformarlo dalla più importante industria culturale del paese pubblica e cioè di tutti, ad “impresa” gestita managerialmente da un solo uomo, il direttore generale, emanazione diretta del governo. Lo sta facendo sistematicamente anche con la produzione culturale. Il governo ed il ministro Franceschini, nel perseguire l’obiettivo dichiarato di “costruire una cultura del mecenatismo” non solo diventano essi stessi “mecenati”, distribuendo a loro piacimento 500 euro ai nuovi “votanti” maggiorenni da utilizzare in consumi culturali – senza minimamente curarsi a quali luoghi della cultura possono permettersi di accedere tutti i giovani durante tutti i giorni dell’anno -, ma elaborano leggi la cui reale impostazione è delegata al governo e cioè sottratta alla discussione pubblica e le cui finalità sono lo smantellamento del ruolo sociale dello Stato.
È questa la filosofia di fondo del nuovo “Schema di disegno di legge in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo dal vivo”, presentato pomposamente in un pranzo di Renzi e Franceschini con i premi oscar del cinema italiano e raccontato ai media in modo molto “approssimativo” e come se fosse già in vigore. Intanto una nota a margine: nello schema di disegno di legge allo “spettacolo dal vivo” sono dedicate in realtà 4 pagine sulle 27 complessive e sono anche troppe perché le sole cose reali che si dicono in quelle 4 pagine è da un lato che la riforma (dal promettente nome di “Codice dello spettacolo”) dei settori della musica, della danza, della prosa, delle fondazioni lirico sinfoniche, del teatro e dei circhi è demandata al governo, che quindi deciderà in perfetta solitudine, e dall’altro che gli investimenti pubblici in quei settori dal 2020 andranno a diminuire. Ma di questo nessuno parla.
Per quanto riguarda le rimanenti 23 pagine dedicate al cinema e all’audiovisivo va detto che è talmente palese la funzione propagandistica ed elettorale dell’annuncio che lo “schema di disegno di legge” non avrà nessuna corsia preferenziale ma seguirà il normale iter parlamentare e vorrei ricordare che al Parlamento è già in discussione la proposta di riforma del cinema presentata dalla senatrice Di Giorgi. Allora la contraddizione che salta agli occhi è che i disegni di legge sono tutte e due di esponenti dello stesso partito, il Pd, ma sono l’uno l’opposto dell’altro.
Sorgono quindi spontanee alcune domande e alcune osservazioni. Che ruolo ha il Partito democratico nell’elaborazione delle proposte di legge? Se ha un ruolo, la responsabile cultura del Pd Lorenza Bonaccorsi di quale legge è promotrice, quella di Franceschini o quella della Di Giorgi? Oppure il partito non conta nulla e sono direttamente i parlamentari ad elaborare autonomamente le leggi, senza neanche parlarsi tra loro e senza parlare con i propri rappresentanti al governo? La Di Giorgi, quando in commissione cultura del Senato arriverà la proposta Franceschini, cosa farà, rinuncerà alla sua e voterà quella del suo ministro? Possono essere domande forse poco interessanti e “fuori tema” ma a me sembrano utili per capire quale idea di democrazia ha il maggior partito italiano e quale ruolo questo partito attribuisce alla propria organizzazione politica, quale al Parlamento e quale al governo.
E la seconda cosa che va evidenziata prima ancora di entrare nel merito è che anche qui l’articolazione concreta della proposta di riforma viene delegata direttamente al governo tramite moltissimi decreti attuativi che saranno in realtà appunto dei veri e propri articoli di legge. Ancora una volta viene meno la possibilità di una discussione collettiva con le forze sociali, culturali e professionali del settore.
Vorrei fare però un’altra osservazione, più generale e più difficile. Quello che colpisce è la fretta con cui alcune associazioni e alcuni singoli operatori del settore hanno ritenuto – non richiesti – di dover mostrare pubblicamente il proprio consenso a questa proposta. E nella maggior parte dei casi basando il proprio parere non sulla lettura del testo di legge ma sul comunicato del ministero, che proprio oggettivo e preciso non è, e prima ancora di aver discusso all’interno delle proprie associazioni sui risultati e sugli effetti che una simile legge produrrebbe sull’intero settore cinematografico ed audiovisivo. Colpisce perché nella nostra storia non è mai avvenuto. Nella nostra storia è sempre esistito un tessuto associativo democratico e partecipato molto radicato e una autonomia, indipendenza e libertà della cultura molto diffusa e molto gelosamente custodita. Credo sia su questo che dobbiamo prima di ogni altra cosa ragionare e discutere tutti insieme, perché ogni volta che la cultura è subalterna alla politica o al potere è tutta la società che fa enormi passi indietro insieme alla stessa democrazia.
Per quanto riguarda il merito del disegno di legge Franceschini si è già aperta una discussione. Provo allora a sintetizzarne i punti principali per poterne evidenziare la filosofia di fondo e i suoi esiti concreti. La finalità della proposta viene enunciata esplicitamente là dove si dice “lo Stato contribuisce al finanziamento del cinema… allo scopo di facilitarne l’adattamento all’evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali ed internazionali ”. Credo che non ci sia un modo più esplicito per dichiarare apertamente che questo governo ritiene che lo Stato debba investire nella produzione culturale non per liberarla dalle logiche e dai meccanismi del mercato ma per eliminare le poche resistenze culturali e artistiche che ancora riescono a sopravvivere e per far sì che sia la domanda a condizionare e determinare l’offerta. Peccato che si stia parlando di cultura, cioè di libertà espressiva e di creatività, peccato che si stia parlando di ciò la cui ragion d’essere di fondo è quella di contribuire alla crescita delle persone, alla formazione di un pensiero autonomo e critico. Si sta parlando cioè di uno di quegli elementi “utili” a rimuovere gli ostacoli che “…impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”. E peccato che si stia parlando dello Stato, cioè dell’istituzione che per la Costituzione ha esattamente questo compito.
Per mettere in atto questa “finalità” viene istituito un “fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”. In questo fondo affluisce annualmente il 12,5 percento delle entrate erariali derivanti dai versamenti Ires e Irap delle imprese di distribuzione cinematografica e televisiva, dell’esercizio, delle televisioni, delle imprese di telecomunicazione e internet. Il ministero sostiene che si starebbe facendo come in Francia, sostiene cioè che in questo modo il settore cinema si “autofinanzia”. Non è vero, perché mentre in Francia esiste un prelievo di scopo, cioè un prelievo aggiuntivo su tutti quei soggetti che sfruttano economicamente i film, secondo questa proposta invece è lo Stato che rinuncia a una parte delle sue entrate prelevando una quota dalla fiscalità generale per destinarla al cinema. Non si chiede ai colossi delle telecomunicazioni e alle multinazionali che fanno proventi con il cinema di versare alcuna quota aggiuntiva. Il sistema cioè non si autofinanzia.
Ma il punto non è questo. Il punto è che la fiscalità generale serve non più a finanziare gli autori e le loro opere, ma per l’85 percento è destinata al credito d’imposta e al finanziamento automatico alle imprese. Di più: l’impresa non percepisce denaro pubblico sul film che vuole realizzare, ma sugli incassi ottenuti da tutte le opere che ha prodotto fino a quel momento. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che se si sposta il sostegno economico pubblico dalle opere alle imprese si sposta il sostegno dalla cultura all’industria e non è cosa da poco. Inoltre se le imprese riceveranno contributi in base agli incassi delle opere già prodotte vuol dire che non riusciranno a sopravvivere tutti quei produttori indipendenti che con enormi sacrifici, spesso mettendo a rischio se stessi, hanno nella loro storia imprenditoriale il cinema d’autore che può anche non avere incassato ma che ha fatto grande nel mondo la cinematografia del nostro paese. Vuol dire che sopravviveranno e vivranno solo tutte quelle imprese che sono già forti, vuol dire che nessuno metterà a rischio la propria media di incassi producendo film “non garantiti” sul mercato.
Resterà un 15 percento per i contributi selettivi alla produzione, alla distribuzione e all’esercizio che saranno attribuiti in base alle valutazioni di cinque “esperti” – individuati in un successivo decreto governativo – in base a modalità applicative anche queste decise con un futuro decreto. Anche per quanto riguarda la “promozione” il disegno di legge non dà alcuna certezza ma è tutto rimandato ad un decreto ministeriale che dovrà individuare “le specifiche tipologie di attività ammesse”, definire “i criteri e le modalità per la concessione dei contributi” e la ripartizione delle “risorse disponibili fra le varie finalità” (cioè le associazioni di cultura cinematografica, la promozione del cinema italiano all’estero, i festival, le rassegne, la conservazione e il restauro delle opere, eccetera).
Solo altri tre punti e considerazioni. Il primo. Viene istituito il “Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo” che sostituisce la attuale sezione cinema della Consulta dello spettacolo e che ha tantissimi compiti, ma tutti consultivi o propositivi. È composto da dieci membri tutti designati dal ministro d’intesa con altri ministeri, di questi dieci membri uno solo è scelto su una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria. Le decisioni sono quindi tutte in mano al ministero, cioè al governo. Naturalmente del Centro nazionale per il cinema richiesto da anni da tutte le categorie non si fa neanche cenno.
Il secondo. La legge equipara sotto tutti gli aspetti l’opera cinematografica e quella audiovisiva, compresi i videogiochi. Il problema non è solo che i fondi dovranno essere divisi tra i due settori, il punto è anche che non si fa distinzione nei criteri tra ciò che ha per destinazione la sala e ciò che è prodotto per il piccolo schermo, e quindi soggetto a logiche di palinsesto e destinato a pubblici completamente diversi da quello cinematografico (e che inoltre riceve già finanziamenti dalle emittenti televisive).
Il terzo. La finta eliminazione della censura. Nel comunicato si dice trionfalmente che “finisce la censura di Stato” (ammettendo che c’era fino ad ora, comunque). In realtà l’operazione vera è quella di introdurre un meccanismo di autocensura. Mi spiego. Si delega ancora una volta il governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme di “tutela dei minori” in base ai seguenti principi: rispetto naturalmente sia della libertà d’espressione che della protezione dell’infanzia; introduzione del principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici; istituzione di un organismo di controllo della classificazione dei film e del suo rispetto. Vuol dire che sarà l’operatore cinematografico (il produttore, il distributore, l’esercente) a stabilire a quale “classe” corrisponde il proprio film e poiché se sbaglia classificazione sono previste delle sanzioni, chi correrà il rischio per esempio di mandare in onda in prima serata un film che forse l’organismo di controllo giudicherà invece vietato ai minori? E quale sala lo proietterà senza divieto?
Qualcuno dà per certo che la legge che passerà sarà questa e in questa versione. Io non credo, o perlomeno spero di no. Penso che ci sia ancora la possibilità di incidere sulle scelte del Parlamento e penso che ci sia tutto il tempo per farlo. Penso che bisognerebbe mettersi intorno a tanti tavoli per discutere tutti insieme e per elaborare tutti insieme le proposte che si ritengono più utili per il cinema e per la cultura in generale. Ma penso anche che perché questo accada bisognerebbe avere la forza di prescindere dai muri delle appartenenze, avere la forza di uscire dalla propaganda renziana per cui chi si oppone alle sue politiche o si piange addosso o ostacola il cambiamento, come se il cambiare fosse di per sé certezza di progresso e miglioramento. Avere la forza di uscire dal “conformismo culturale” che rischia di uccidere questo paese.
Stefania Brai è responsabile nazionale cultura PRC-SE
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti