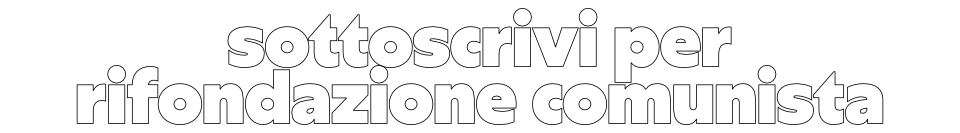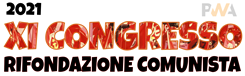Per l’istruzione pubblica, «casa di tutti»
Pubblicato il 23 mag 2013
Non c’è solo il problema dell’esclusione, bensì il tema dei saperi, che è al cuore della post-democrazia.
Colin Crouch scriveva nel suo saggio Postdemocrazia (Laterza, 2003) che una società post-democratica è una società che continua ad avere e a utilizzare tutte le istituzioni democratiche, nonostante esse diventino nel tempo poco più che contenitori formali. La descriveva come un’arte di governare la società in cui spesso «la politica viene decisa in privato dall’interazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici», in un processo di commercializzazione della cittadinanza entro il quale i diritti vengono messi sul mercato. Un declino inevitabile della democrazia dunque? No, «fintanto che la fornitura dell’istruzione, dei servizi sanitari e degli altri servizi tipici del welfare state non saranno subappaltati a estese catene di fornitori privati» continua Crouch nella sua argomentazione.
Si è parlato molto, ultimamente, di post-democrazia: la trasformazione della politica in un processo amministrativo decentrato, del processo politico in un sondaggio d’opinione, e la privatizzazione del sistema pubblico richiamano in modo inquietante l’equiparazione del sistema italiano alle post-democrazie inglese e americana. Eppure, al momento dell’uscita del suo libro Crouch aveva definito l’Italia come il simbolo stesso della post-democrazia, non solo per la proliferazione di specialisti, tecnici o pessimi persuasori, ma anche per la vitalità dei processi di democrazia diretta. Pensiamo al referendum contro la privatizzazione dell’acqua, ma anche al referendum consultivo sul finanziamento pubblico alle scuole private previsto a Bologna per il 26 maggio 2013.
La campagna referendaria organizzata dal Comitato Articolo 33 ( a questo indirizzo si raccolgono le firme di adesione) è appena iniziata, accompagnata da un alto numero di firme: da Rodotà a Landini, da Settis a Gallino. La storia del referendum nasce con la legge sulla parità scolastica, a partire dalla quale i finanziamenti alle scuole private sono cresciuti di anno in anno sino a superare nella sola Bologna il milione di euro. Di converso, è cresciuto ogni anno il numero di bambini esclusi dalle scuole d’infanzia comunali e statali, arrivando a giugno del 2012 a 423 bambini in lista d’attesa. La stessa cosa è avvenuta sul piano nazionale, dalla scuola all’università, dove i tagli al finanziamento pubblico hanno significato sempre più spesso numero chiuso e difficoltà d’accesso. In questo contesto, lo scopo del referendum è chiedere alla cittadinanza dove preferisca allocare i finanziamenti pubblici, affinché le famiglie non siano costrette a iscrivere i bimbi esclusi a una scuola privata pagando delle rette talora molto alte.
C’è un paradosso, in tutto questo. Il principio che sostiene il finanziamento alle paritarie, infatti, è la «libertà di scelta», principio che mette d’accordo tanto i sostenitori della teoria neoliberale quanto quelli della sussidiarietà. Però, ironia vuole che non solo l’allocazione dei fondi pubblici alle scuole private abbia dissestato, negli anni, l’istruzione pubblica – si pensi a quanto è avvenuto negli Stati Uniti con la No Child Left Behind – ma che, nel nome della libertà di scelta, i genitori siano oggi spesso obbligati a iscrivere i loro figli a scuole confessionali (25 su 27 a Bologna). Altro che libertà di scelta. Al cuore del referendum, pertanto, non c’è solo il problema dell’esclusione, bensì il tema dei saperi, un tema che siede al cuore della post-democrazia.Qui la questione non è solamente l’accesso bensì i saperi il principio per cui diceva Freire «l’educazione può portare al conformismo; oppure diventare pratica di libertà».
Gli estensori di quest’articolo vengono da opzioni laiche o di fede, da storie diverse, da generazioni diverse, da collocazioni diverse nell’ambito della sinistra ma si ritrovano tutti nel comune valore che la scuola e l’università pubblica – intese come «luoghi del libero dialogo» e come centri fondamentali dei processi educativi, formativi e di ricerca – siano la forma più idonea e consona perché tutti usufruiscano di un sapere che sia realmente «aperto a tutti e di tutti».
Ciò non esclude che assieme alla scuola pubblica vi siano scuole di tendenza e di orientamento unilaterale, ma è evidente che questa possibilità non può realizzarsi a scapito della scuola pubblica ma deve compiersi e svolgersi «senza oneri per lo stato».
La nostra adesione alle ragioni dell’abolizione del finanziamento pubblico alle scuole private non è, quindi, esclusione delle scuole di tendenza, non è azione intesa a mantenere in vita «storici steccati», ma a rispettare il dettato costituzionale.
È un modo coerente per intendere la laicità come valore fondante del nostro stato e della nostra istituzione. È una scelta per testimoniare che credenti e non credenti credono realmente nella libertà come valore-fine rifiutando ogni strumentalizzazione.
Solo in questa prospettiva «pubblico e privato», non solo possono convivere, ma possono dimostrare le loro potenzialità, senza che si ricorra a interpretazioni estensive o di comodo, convinti come siamo che l’art. 33 della Costituzione assicura a tutti «libertà della scuola e libertà nella scuola», dalle primarie all’Università.
*Alessandro Arienzo, docente univ. Federico II, provinciale Flc; Francesca Coin, sociologa, Università Cà Foscari; Pasquale Colella, professore emerito di Diritto ecclesiastico univ. Salerno, direttore della rivista «il Tetto»; Ugo M. Olivieri, docente univ. Federico II , membro della rivista «il Tetto»
Il Manifesto – 23.05.13
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti