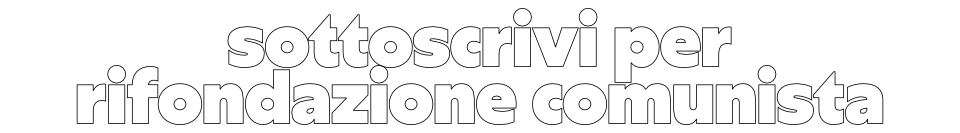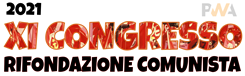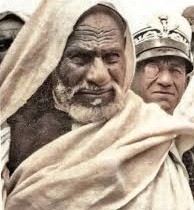
Il colonialismo non porterà mai pace e giustizia
Pubblicato il 17 set 2025
Antefatto
Il 16 settembre del 1931, in pieno regime fascista, l’occupazione coloniale in Libia, la cosiddetta “quarta sponda”, registrò uno dei tanti crimini destinato a restare impuniti. Dopo pochi giorni di processo sommario, il capo della resistenza all’occupante, l’anziano imam senussita Omar al-Mukhtār, venne impiccato nella pubblica piazza, come esempio di monito rivolto verso chiunque osasse ribellarsi alle truppe fasciste e del Regio esercito. Erano state radunate a forza oltre 20 mila persone per assistere all’impiccagione del “Leone del deserto”, come veniva chiamato, l’uomo che diresse il movimento partigiano in Cirenaica e Tripolitania, infliggendo negli anni numerose sconfitte all’esercito italiano. Per combatterlo si avvicendarono diversi comandanti che usarono i metodi più duri per convincere le popolazioni a sottomettersi, centinaia di migliaia di libici furono trasferiti in campi di concentramento sulla costa e addirittura si giunse a realizzare un reticolato per impedire ai combattenti di attraversare il confine con l’Egitto. E poi rastrellamenti, bombardamenti, requisizione e occupazione delle oasi, utilizzo dell’iprite, arma proibita da ogni convenzione internazionale, per affermare il controllo del territorio. Fu il generale Rodolfo Graziani a imporre la deportazione nelle fasce costiere di tutti gli abitanti dell’oasi di Gebel, oltre 100 mila persone, di queste, almeno 60 mila, soprattutto donne e bambini, morirono durante un cammino di oltre 1000 chilometri a causa di stenti, febbri, uccisioni sommarie ad ogni minima reazione. Vennero distrutti ovviamente i villaggi e ucciso o razziato il bestiame, ogni forma di patrimonio di chi non si assoggettava doveva essere confiscata. Sono usciti volumi su quei crimini iniziati con l’Italia liberale nel 1911 e proseguiti col fascismo, di cui mai nessuno ha dovuto rendere conto. Ci furono anche settori progressisti italiani che pensarono alle opportunità che questa occupazione avrebbe potuto garantire ai coloni italiani provenienti dal Meridione: terre, lavoro, ricchezza, ci fu chi definì l’Italia “la Grande proletaria”. L’uccisione di al-Mukhtār, peraltro contraria anche agli stessi codici di guerra, secondo cui non poteva essere processato per rivolta chi non si era sottomesso, non fermò la resistenza libica. E il Leone divenne un eroe anticoloniale per gran parte del mondo arabo. Anche dopo la Liberazione, coloro che avevano commesso tali violenze, non vennero affatto puniti. Lo stesso Graziani, divenuto poi tristemente noto per i massacri in Etiopia, fu condannato a una pena irrisoria per aver aderito alla RSI, ma non per le atrocità coloniali. Questa parte di storia, come quella di tutti i crimini commessi durante l’occupazione, divenne nota da noi non solo grazie al lavoro di alcuni storici, e ad un film.
Nel 1980, tanti anni dopo, il regista Mustafa Akkad raccontò la vicenda in un lungo film “Il leone del deserto”. Godendo del finanziamento del leader libico Gheddafi, con un cast stellare: Anthony Quinn come protagonista, Rod Steiger, Oliver Reed, Raf Vallone e Irene Papas, il film giunse anche a Cannes. In Italia fu subito attaccato in quanto “ledeva l’onore dell’esercito”, gira ancora la leggenda nera per cui fu censurato in realtà accadde di peggio. Nessun distributore si rese disponibile a doppiarlo e a pagare i diritti per la sua diffusione, quindi non uscì mai se non tanti anni dopo. Una sorta di autocensura di mercato e culturale.
La pellicola ebbe una grande diffusione nel mondo arabo, contribuendo a rilanciare la leggenda del grande patriota.
Un piccolo fatto di cronaca
E qui mi ritrovo a parlare in prima persona. Negli anni fra il 1988 e il 1991, insieme ad altre compagne e compagni dalla più disparata provenienza politica, ci recavamo in Palestina per sostenere quella che divenne nota come la “rivolta delle pietre”, la prima Intifada (sollevazione). Erano ragazzini a lanciare sassi contro gli occupanti armati di tutto punto. E i soldati di Tsahal rispondevano sparando ad altezza d’uomo. Oltre 1.200 le vittime accertate di cui molti minorenni. Eravamo in un villaggio nei pressi di Ramallah, non ricordo esattamente la data, quando venimmo circondati da un gruppo di adolescenti ognuno con una pietra in mano. Quello che sembrava il capo ci chiese in inglese da dove venivamo. Alla risposta “Italia”, reagì dicendo: “Ah voi siete quelli che hanno ammazzato Omar al-Mukhtār”. Gli sguardi degli altri si incupirono e ognuno di loro cominciò ad agitare con aria affatto rassicurante la pietra che aveva in mano. Con un colpo di intuito inaspettato uno dei nostri, senza mostrare timore rispose “Si ma i nostri partigiani sono quelli che hanno fucilato chi ha dato l’ordine di uccidere Omar al-Mukhtār. Noi siamo qui grazie al loro esempio”. L’atmosfera cambiò di colpo. Il leader del gruppo ci invitò a casa della sua famiglia a bere the e biscotti. Ci sentivano come loro alleati.
Perché raccontarlo?
Nelle ore in cui ricorre questo anniversario, così come le stragi di Sabra e Chatila. Erano due campi profughi nelle vicinanze di Beirut, in Libano, che subirono l’attacco dei falangisti cristiano maroniti, col sostegno dell’esercito israeliano nel 1982 in cui vennero trucidate quasi 3500 persone, in gran parte donne e bambini palestinesi, vale la pena fare un ragionamento con la storia. Intanto col fatto che lo sterminio di parte della popolazione libica in periodo coloniale e le modalità con cui venne effettuato, quello in Libano, al di là di strumentazioni tecnico militari di volta in volta, meno potenti di oggi, dovrebbe ricordare a molte /i qual è il risultato di simili eccidi. La ferita resta, si imputridisce, il rancore e l’odio si trasmettono di generazione in generazione e diviene impossibile fermarlo. Scrivere di queste cose oggi, mentre sembra che si stia tentando di mettere la parola fine sul genocidio a Gaza, costringe a riflettere in maniera diversa. Siamo su un crinale fondamentale della Storia, quella che magari potrebbe anche portare ad una temporanea fine di qualsiasi aspettativa per il popolo palestinese e a segnare un passo in avanti verso la creazione di quella “Grande Israele”, auspicata dal sionismo non da oggi.
Si compie il crimine ma poi? Dall’incubo di cui si rendono colpevoli i governanti del regime di quello che oramai è divenuto uno Stato etnico, godendo del sostegno di gran parte della sua popolazione, non potrà mai uscire pace né in Medio Oriente né altrove. Senza giustizia per un popolo che ha subito quanto ha subito quello palestinese, la ferita inferta resterà profonda per gran parte del pianeta. Oggi non esistono soluzioni che possono minimamente sperare di sanare quanto prodotto in termini di odio, rancore, rifiuto generalizzato. Oggi c’è un salto nel vuoto e chi, come i governi occidentali, hanno scelto di sostenere le orrende scelte di terrore, non potranno sentirsi in pace, saranno equiparati a quelli che un tempo uccisero Omar al-Mukhtār, per loro non ci saranno rispetto o perdono. E per chi ha scelto di stare dalla parte degli oppressi non potranno esserci passi di arretramento. Si dovrà essere fra coloro che concretamente continueranno ad opporsi ai progetti coloniali nell’area, a non limitarsi a criticare il governo Netanyahu e la sua banda di nazisti, si dovrà mettere in discussione un progetto coloniale che ha prodotto unicamente distruzione e morte, altro che unica democrazia in Medio Oriente. Si avrà il coraggio di farlo?
*Transform Italia
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti