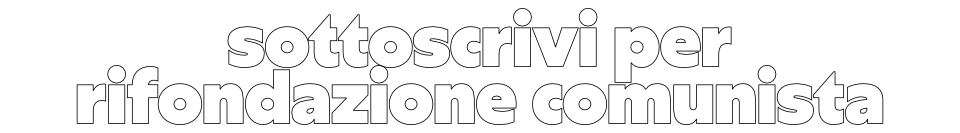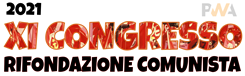Ricordando Fernanda Pivano
Pubblicato il 19 ago 2025
Stefano Galieni*
«Vuoi sapere se sono stata a letto con Hemingway? No». Iniziò così un’intervista che ancora ricordo con immenso piacere, fatta per Liberazione tanti anni fa, sotto le mura di Castel S. Angelo e di cui non ricordo la data, che sto cercando reperire. Avevo svariati anni di meno e mi ritrovavo davanti ad una delle intellettuali che più ammiravo e che non avrei mai pensato di poter incontrare, Fernanda (Nanda) Pivano. Ricorre l’anniversario della sua scomparsa, 16 anni fa e provo a ricordare le tracce di quell’incontro. Davanti ad un’enorme bicchiere di Coca Cola, si era accorta perfettamente di quanto mi sentivo intimidito in quell’incontro. Si raccontava con leggerezza, come se fosse stata unicamente una testimone di fatti più grandi di lei e di persone immense nel mondo della letteratura, della poesia, della vita vissuta senza frontiere ad ogni parola mi sembrava di assorbire quell’immensa forza di vivere che aveva portato con le sue traduzioni che andavano ben oltre il lavoro di ricerca delle parole giuste. Nanda amava le persone che aveva, traducendole, portato in Italia. Alcuni non le aveva conosciute per ragioni anagrafiche, come Edgar Lee Master. Chi di noi avrebbe avuto altrimenti il privilegio di crescere l’Antologia di Spoon River. Altri, conosciuti direttamente e con passione, non solo Hemingway, ma Kerouac, Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Corso, Ferlinghetti, Miller e Bukowski e tanti altri che o sono stati da lei tradotti o valorizzati, fatti conoscere in Italia. Mi parlò di queste figure mitiche e dalla vita a dir poco complessa, come di persone stupende e pulite, Bukowski che si presentava a casa sua con mazzi di fiori, Corso, morto, pochi anni prima, con la sua disperazione incompresa e la cui tomba è nel cimitero acattolico nei pressi di quelle di Shelley, di Keats e di Gramsci.
“I miei genitori – mi disse – quando arrivavano i giovani dell’alta borghesia piemontese, mi avvisavano di stare attenta e di non farmi mettere le mani addosso mentre quando venivano in casa autori oggi celebrati, spesso vestiti come potevano e con alto tasso alcoolico, mi lasciavano uscire tranquillamente e si fidavano di questo mondo, così fuori dai margini. Mi parlò molto di De Andrè, con cui aveva collaborato per la traduzione di poesie dell’Antologia di Spoon River, per un album straordinario come “Non al denaro né all’amore né al cielo”. Mi ripeteva una frase per cui divenne nota “Non è vero che Fabrizio era il Dylan italiano. È vero il contrario”. E poi i racconti resi vividi di Gregory Corso, in giro per Piazza Navona, troppo ubriaco per tenersi in piedi, del carattere, di Jack Kerouac, intervistato, anche lui visibilmente alticcio, nel 1966 per la Rai (il video è ancora reperibile) e di cui Pivano aveva quasi imposto la pubblicazione di “Sulla strada”, manifesto straordinario della Beat Generation. Si deve anche a questa grande intellettuale e a quello che fu un suo professore, Cesare Pavese, l’arrivo in un Paese provinciale di una ventata di libertà, pacifismo, contrasto al militarismo e all’autoritarismo di cui ancora oggi sentiamo l’esigenza. Allora una parte importante della cultura Usa, dello spot, della musica, si imponeva per una rottura da sinistra con l’establishment bigotto, reazionario e razzista. E chi se le scorda quelle due ore trascorse a sentire parlare di un mondo fantastico, attraverso le sfumature caratteriali, il racconto degli sguardi e delle debolezze, l’anima profondamente libertaria che animava Nanda Pivano stessa. Non era una traduttrice, figura preziosa, era una delle persone che in quel nuovo mondo aveva trovato una propria dimensione e la restituiva a chi intanto iniziava a ribellarsi anche in Italia. Uscì anche un aneddoto – lei nata nel 1917 era ovviamente antifascista – che vide coinvolto suo fratello. Nel 1943, in piena guerra, aveva stipulato un contratto con Einaudi per la traduzione di Addio alle armi, di Hemingway, odiato da Mussolini sin dall’inizio del regime. In quel periodo era stato Hemingway ad intervistare il futuro duce che aveva definito “un enorme bluff”. Il contratto però era stato firmato dal fratello di Nanda, Franco che venne per tale ragione arrestato da un comando delle SS e portato in caserma a Torino. Ovviamente la sorella si recò per rivendicare di essere lei la traduttrice. Lui venne liberato, lei tratta in arresto lungamente interrogata. La salvò forse il fatto di provenire da famiglia altolocata. Quel libro era infatti un concentrato di antimilitarismo che, a detta del regime offendeva l’esercito italiano per come raccontava la disfatta di Caporetto. E parlava di queste storie come se fossero sciocchezze di gioventù dovute all’incoscienza, dei grandi autori incontrati, tradotti e portati da noi, come di amici con cui si condivide una bevuta. Le feci leggere, prima di farla pubblicare, la sintesi dell’intervista che copriva un intera pagina di Liberazione. Il commento fu sintetico “Mi piace. Non sembra fatto da un giornalista”
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti