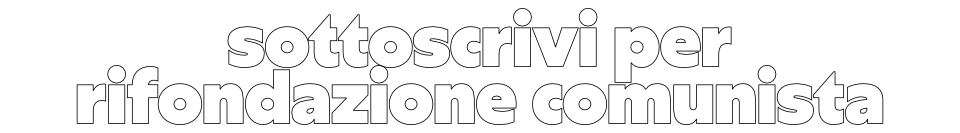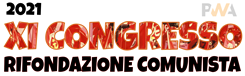La trasmutazione della Fabbrica Italiana Automobili Torino: dalla vocazione industriale alla finanza
Pubblicato il 4 ago 2025
di Dino Greco -
La vendita di Iveco al gruppo indiano Tata Motors e della Divisione Difesa a Leonardo, da parte di Exor N.V., la holding finanziaria della famiglia Agnelli, non è che l’ultimo episodio del progressivo abbandono, da parte dell’ex gruppo torinese, non solo dell’automotive, ma della propria originaria vocazione industriale, per approdare alle “magnifiche sorti e progressive” della finanza.
E’ di una imbarazzante eloquenza il commento di Giorgio Garuzzo, ex-dirigente di alto livello di Fiat oltre che ex-amministratore delegato della stessa Iveco.
Garuzzo non ha usato mezzi termini, spiegando che il solo interesse di Tata “è quello di acquisire la vasta rete di vendita di Iveco e sfruttarla come canale di diffusione dei suoi veicoli commerciali”.
In uno scenario del genere – continua Garuzzo – “andrebbero in crisi i prodotti Iveco, soprattutto i veicoli leggeri, quindi lo stabilimento ex Sofim di Foggia […] e quelli di Brescia e Suzzara”. Inoltre, considerato che Tata utilizzerebbe componentistica indiana per i suoi mezzi, a rimetterci saranno anche “tutti i sub-fornitori di Iveco, che in Italia sono un migliaio, specie al Nord”.
La storia ci ha reso troppo avvertiti per non sapere che le “garanzie” dichiarate congiuntamente, secondo un collaudato copione, da venditore ed acquirente, in base alle quali, almeno per i prossimi due anni, “non verrà chiuso alcun impianto o sito produttivo di proprietà o utilizzato da Iveco Group e non sarà ridotta la forza lavoro”, non sono che uno sciame di lucciole, parole mendaci, del tutto simili a quelle che nel corso degli anni hanno costellato riduzioni della produzione e del personale in tutti gli ex-stabilimenti Fiat, poi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e infine Stellantis, con sede legale ad Amsterdam, frutto della fusione fra FCA e il gruppo francese PSA (che comprendeva i marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall) a decretare l’eutanasia della produzione di auto in italia.
Garuzzo è passato poi a criticare la linea più generale di Exor, guidata da John Elkann. “La holding – ha detto – ha venduto Magneti Marelli a Kkr, ora fallita; poi è toccato a Comau, svenduta anch’essa, e infine a Iveco, solo per citarne alcune. Eravamo una potenza e abbiamo svenduto l’industria, rischiamo di essere un Paese del terzo mondo fuori dalla sfida tecnologica, un disastro generazionale. La cessione dell’ex Fiat ai francesi con Stellantis è stato il disastro finale”.
Difficile dire meglio di così.
Ma la storia degli imbrogli della Fiat a danno dei lavoratori e del paese è lunga e affonda le radici nel solido rapporto con il potere politico, sul quale la famiglia Agnelli ha sempre potuto contare.
Limitando lo sguardo agli ultimi anni della Repubblica, vale ricordare che nel 1967 nacque “Sicilfiat”, una società a partecipazione pubblica, di cui la FIAT deteneva il pacchetto di maggioranza con il 60% delle azioni e la Regione Siciliana il restante 40% tramite la So.Fi.S prima e poi tramite l’ESPI (Ente siciliano per la promozione industriale).
Lo stabilimento fu completato nel 1970 nel territorio comunale di Termini Imerese, grazie ad un consistente contributo della Regione erogato al gruppo Fiat per ottenerne la localizzazione nel territorio, con un’occupazione iniziale di 350 addetti.
Nel 1977 la Fiat acquisì la totalità delle azioni, per cui lo stabilimento divenne uno dei tanti del gruppo con una forza lavoro che era in quel momento di circa 1500 addetti.
Sergio Marchionne, l’AD della Fiat, riconobbe che, con l’avvio del lavoro articolato su tre turni, l’azienda era divenuta un modello produttivo. Nella seconda metà degli anni Ottanta a Termini erano occupati 3.200 operai con almeno 1.200 nell’indotto. Ma nel 1993 la prospettiva cambia completamente. Per rispondere alla crisi del settore auto fu attuata la prima ristrutturazione aziendale col ricorso massiccio alla cassa integrazione. Il numero di occupati continuò a scendere fino ai 1900 dell’ultimo periodo di vita dell’azienda.
Nel gennaio 2010, durante il suo intervento all’Automotive News World Congress organizzato al Renaissance Center di Detroit, Marchionne affermò categoricamente l’irrevocabilità dei piani di chiusura della fabbrica siciliana che avvenne il 26 novembre del 2011. Senza un minimo di ripensamento, la Fiat si sottrasse anche all’impegno di ricercare soluzioni alternative, e tutte le ipotesi di salvataggio e di riconversione naufragarono ancor prima di nascere.
Dal 1º gennaio 2015 lo stabilimento passò alla newco Blutec, società del gruppo Metec (Stola) per la produzione di componenti per auto, con il sostegno di finanziamenti erogati da Invitalia. Lo stesso anno vennero riassunti novanta operai, già in cassa integrazione, ma solo per una preparazione operativa dei futuri lavori. Con l’acquisto e l’arrivo dei macchinari e le necessarie modifiche degli impianti lo stabilimento sarebbe dovuto tornare a produrre auto, ma di nuovo tipo: ibride ed elettriche. Il programma tuttavia rimase inattuato; sorsero problemi relativi al finanziamento di Invitalia.. Tutte le dichiarazioni d’intenti rimasero tali. Nessuna attività concreta ebbe mai inizio.
Dulcis in fundo, nel marzo del 2019, il presidente Roberto Ginatta di Blutec e l’amministratore delegato Cosimo Di Cursi furono posti agli arresti domiciliari per malversazione ai danni dello Stato. La Guardia di Finanza mise sotto sequestro anche la fabbrica e 16 milioni di euro.
Una nota di involontaria, macabra ironia: il viale principale del sito produttivo mai nato era stato rinominato “Viale 1º maggio”.
Andiamo avanti.
Erano passati molti anni da quel terribile 1980, quando il più duro e simbolico episodio di lotta di classe della storia repubblicana si consumò davanti ai cancelli della Fiat ed ebbe come epilogo la resa del sindacato e il licenziamento di massa, sebbene mascherato dalla cassa integrazione a zero ore, di 14 mila lavoratori e lavoratrici dello stabilimento torinese.
Nel gennaio del 1987 la Fiat ebbe in regalo l’Alfa Romeo dall’IRI (Prodi) e dallo Stato (Craxi, Andreotti, Amato, Darida e compagnia cantante). Costoro, all’unisono, respinsero, nel nome dell’italianità – almeno così dissero – la proposta della Ford, nettamente migliore, tanto sul piano industriale quanto su quello occupazionale, di quella della casa torinese.
In questo caso, il “mantra” liberale degli effetti benefici della concorrenza dovette arrendersi di fronte alle cospicue mazzette che la Fiat erogò urbi et orbi.
Luciano Lama, fino a poco prima segretario della Cgil, si lanciò in questa anodina dichiarazione: “Preferisco vendere alla Fiat, ma se fossi uno dell’Alfa preferirei la Ford”: questioni di opportunità politica e sindacale…
La casa torinese si impegnò solennemente a mantenere nell’organico tutti lavoratori di Arese e Pomigliano e potè così impadronirsi del “Biscione” pagando allo Stato quattro soldi, con cinque “comode rate” annuali, a partire dal 1993! Ma già nel novembre dello stesso anno la Fiat ridusse a 4.000 i lavoratori in forza ad Arese e lo stesso salasso praticò, come vedremo, a Pomigliano.
In conclusione, mentre la Fiat si sbarazzava progressivamente di 28.000 lavoratori Alfa Romeo riceveva in dono dallo Stato 2.000 miliardi per Arese e Pomigliano e ne incassava altri 1.000 per costruire gratis lo stabilimento di Melfi, di cui ci occuperemo fra poco.
Lo stabilimento di Melfi fu costruito fra il 1991 e il 1993, in una zona agricola, con un investimento complessivo di 6,6 miliardi di Lire, quasi per la metà coperti da sovvenzioni statali.
La produzione ebbe inizio nel gennaio 1994 con il modello Fiat Punto. Da allora e fino al 17 maggio 2010, 5.000.000 veicoli uscirono dalle catene di montaggio della fabbrica melfitana.
La scelta di collocare il complesso industriale proprio nel cuore della Basilicata fu considerata dalla Fiat “strategica”, dato il suo particolare insediamento geografico su una direttrice che collega bene la Basilicata con la Puglia e la Campania, ossia a pochi km dall’uscita autostradale di Candela sulla A16 Napoli-Canosa e sulla SS655 Bradanica, che collega Foggia a Matera.
Ma la vera scelta strategica, tutta politica, fu quella – e così fu dalla Fiat stessa definita – del “prato verde”, vale a dire dell’investimento industriale in un luogo dove la manodopera, proveniente dalle campagne, per lo più priva di storia sindacale, si sarebbe prestata ad ogni sorta di pressione e richiesta aziendale, sopportando ogni sorta di flessibilità ed imposizione in cambio dell’agognato lavoro.
Non si sbagliava, la Fiat: lo stabilimento di Melfi fu classificato come una delle fabbriche con la più alta produttività del mondo.
Si leggeva, nella pubblicità di Stellantis, che “lo stabilimento, dal quale escono complessivamente 1.300 Fiat Punto e Lancia Y al giorno, rappresenta uno degli esempi più emblematici dell’evoluzione organizzativa del lavoro che ha portato la Fiat Auto a realizzare la fabbrica integrata modulare (FIM). La fabbrica integrata è un modello organizzativo ispirato ai principi della “produzione snella” (integrazione delle funzioni e dei compiti a tutti i livelli, decentramento del potere decisionale, accorciamento della catena gerarchica, trasparenza informativa). La produzione modulare, che mantiene tutti i principi della lean manufacturing e della fabbrica integrata, aggiunge, da una parte, la possibilità di realizzare una maggiore varietà e variabilità di prodotto, ridefinendo il ruolo dei fornitori e riduce, allo stesso tempo, la complessità produttiva attraverso la riduzione della quantità delle parti da assemblare e la semplicità delle operazioni”.
Ma c’era anche qualcos’altro. Melfi diventava la prima fabbrica automobilistica, perlomeno in Europa, con il pieno utilizzo degli impianti per 24 ore giornaliere per sei giorni la settimana, comprensivi del sabato, con l’attività lavorativa articolata su tre turni strutturali a rotazione con riposi a scorrimento basati su schemi plurisettimanali a livello individuale di due settimane consecutive a 48 ore e la terza a 24, fissando in questo modo la media dell’orario contrattuale di 40 ore. Anche la manutenzione degli impianti ad alta automazione era organizzata su tre turni strutturali di 8 ore a rotazione, ma per sette giorni la settimana, onde permettere la manutenzione straordinaria a lavorazioni ferme.
L’aumento della capacità produttiva installata a Melfi (circa 600.000 vetture/anno) ebbe come conseguenza la razionalizzazione e riorganizzazione degli impianti considerati obsoleti del Nord: nello spazio di qualche anno si dismisero gli stabilimenti di Chivasso, Arese e Rivalta.
Ma la “modernità” tecnologica e organizzativa aveva un rovescio: il sacrificio imposto alla condizione operaia.
Per molti anni i lavoratrici e i lavoratori di Melfi subirono in silenzio. Poi, come talvolta accade, quasi improvvisamente, scoppiò la scintilla, quella che li portò a comprendere ciò che Giuseppe Di Vittorio considerava il primo e fondamentale atto di ribellione: la comprensione che “il padrone non ti dà il lavoro; il padrone il lavoro se lo prende”.
Fu così che nel 2004 gli operai della fabbrica melfitana avviarono uno sciopero che bloccò la produzione per 21 giorni.
Le principali rivendicazioni erano l’equiparazione dei salari (lì inferiori del 20% rispetto a quelli degli altri stabilimenti Fiat in Italia) e l’abolizione della doppia battuta, ovvero l’obbligo, in vigore dal 1993, di svolgere per due settimane consecutive lo stesso turno (incluso il turno di notte). La doppia battuta, applicata unicamente nello stabilimento di Melfi, non era altro che una violenta ipoteca sui ritmi di vita e di riposo e come tale era vissuta dagli operai dalle operaie che il 19 aprile 2004 “assediarono” la fabbrica e resistettero per 21 giorni, con determinazione e orgoglio, alle cariche della polizia che intervenne per fiaccare la determinazione operaia a continuare la lotta.
Al termine del durissimo scontro, le principali richieste furono accolte, con un accordo tra la dirigenza Fiat e le principali organizzazioni sindacali.
Ma nel 2010 gli scioperi ripresero. Questa volta per protestare contro la riduzione unilaterale delle pause e la pretesa della direzione aziendale di un aumento della produttività del 10%, a fronte di una diminuzione del numero degli addetti, molti dei quali consegnati alla cassa integrazione.
Durante le proteste, tre operai, Giovanni Barozzino, Marco Pignatelli e Antonio Lamorte, furono accusati di aver bloccato le macchine. Vennero licenziati in tronco e denunciati con l’accusa di sabotaggio.
Sia il Tribunale di Melfi, sia la Corte di Appello respinsero le accuse dichiarandole infondate.
Dopo la sentenza di appello gli operai avrebbero dovuto essere reintegrati in fabbrica. Ma i vertici Fiat posero come condizione che i tre, pur percependo il salario e potendo svolgere liberamente attività sindacale, non fossero riammessi alle linee di montaggio. I tre operai continuarono ad esigere la completa reintegrazione nel loro posto di lavoro, diritto che fu riscattato solo dopo la sentenza di Cassazione del settembre 2013.
In quello che fu il modernissimo stabilimento della Basilicata restano oggi solo 5mila dipendenti (la promessa era di 10 mila posti di lavoro) di cui due terzi in cassa integrazione. E con una riduzione del 60% della produzione, le garanzie di rilancio della multinazionale suonano vuote.
L’impianto inaugurato nel 1993, risultato nei primi anni duemila una delle fabbriche automobilistiche più produttive al mondo e che alla fine anni ‘90 la Fiat considerava il proprio “gioiello”, oggi rischia di svuotarsi. E Stellantis invita gli operai di Melfi a trasferirsi in Serbia, a kragujevac, dove – si dice- si assemblerà la nuova Grande Panda.
Ma cosa è accaduto a kragujevac, nell’azienda serba ex- “Crvena Zastava” (“Bandiera rossa”), dopo che i bombardamenti della Nato, cui partecipò con entusiasmo il governo italiano, diretto da Massimo D’Alema (ministro della Difesa, Sergio Mattarella) l’avevano completamente distrutta?
L’azienda, ridotta ad un rottame, fu rilevata dalla FCA ed oggi – dopo 10 anni di incentivi pubblici del governo serbo, condizioni fiscali che è eufemistico definire di favore e salari operai ridotti all’osso – è in mano a Stellantis col 67% delle azioni, il resto in collo all’esecutivo di Belgrado.
Le cose, una volta di più, non sono andate però come promesso. Nel 2015, stando ai bilanci della stessa FCA, le 500L uscite da Kragujevac furono meno della metà, 91.769. Nel 2018 appena 56.303. Nel 2020 (ultimo anno disponibile) addirittura 23.272, neanche il 10% del target iniziale, tanto che quell’anno la società serba fece registrare una perdita a bilancio di oltre 20,1 milioni di euro (2,3 miliardi di dinari serbi). Identico trend per l’occupazione. Si è passati da 3.200 lavoratori nel 2016, a 2.400 a fine 2019, agli attuali 2.016. La fabbrica ora è praticamente ferma.
Ora Stellantis, che si rifiuta di incontrare il sindacato, intende tagliare 1500 posti di lavoro su 2000. Ai lavoratori offre quella che chiama una “opportunità di lavoro” che consiste nell’accettare un’ipotesi di trasferimento lavorativo nelle proprie aziende (Slovacchia, Polonia, Italia, Germania) con l’aggiunta, però, che “l’alloggio è a carico dei dipendenti”. Insomma, una grottesca proposta di migrazione, identica, anche se in direzione geografica inversa, a quella proposta agli operai di Melfi!
Gli scioperi indetti da “Samostalni sindikat metalaca” (Sindacato metalmeccanico serbo indipendente) non sono sino ad ora riusciti a modificare la tendenza in corso.
Quanto all’insediamento polacco, basti ricordare che la Fiat ha chiuso la sua storica fabbrica a Bielsko Biala, licenziando quasi 500 operai. Lo ha comunicato Wanda Struzyk, la presidente dell’organizzazione sindacale Solidarnosc sul quotidiano locale Dziennik Zachodni. “E’ la notizia che abbiamo temuto da tempo”, ha commentato. Ma pare che Stellantis abbia detto che una parte dei 486 licenziati – non ridete, per favore – potrà trovare lavoro in altri stabilimenti del gruppo in Polonia, a Tichy o Skoczow: la recidivante proposta dell’esodo come falsa, oltre che irridente, alternativa al licenziamento.
Conviene ora tornare in Italia, per esaminare cosa nel frattempo accadeva negli stabilimenti italiani, dove Sergio Marchionne, idolatrato in quel periodo come il nuovo guru dell’imprenditoria italiana, preparava una generale e definitiva resa dei conti con il sindacato.
Correva l’anno 2010 quando l’amministratore delegato della Fiat, che aveva già dichiarato di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese, annunciò il varo di un mirabolante piano, denominato “Fabbrica Italia”, che prevedeva un investimento di 20 miliardi di euro nel quadriennio 2010-2014, con il raddoppio delle produzioni in Italia e, in particolare, un “impegno per il futuro” di Pomigliano di 700 milioni di euro, tramite il trasferimento delle produzioni della nuova Panda fino a quel momento realizzata in Polonia.
La condizione “non negoziabile” di questo progetto consisteva nell’accettazione, da parte degli operai di Pomigliano di draconiane condizioni che peggioravano i rapporti di lavoro: 3 turni giornalieri di lavoro di lavoro, dal lunedì al sabato compreso, una nuova metrica (il sistema di assegnazione e misurazione dei tempi e delle diverse fasi di lavoro), un impegno a superare le anomalie presenti, soprattutto in tema di assenteismo, drastiche limitazioni del trattamento economico di malattia, dei permessi, delle ferie e dei diritti sindacali.
Marchionne non si accontentò dell’immediata, corriva adesione al progetto di Fim e Uilm. Fece molto di più: pretese che fossero gli stessi lavoratori, direttamente, attraverso un referendum, a mettersi il capestro intorno al collo.
Il battage mediatico, la pressione sui lavoratori furono fortissimi. Furono fatte profezie di sventura nel caso in cui i lavoratori avessero respinto quell’autentico dictat.
Malgrado tutto ciò la votazione non si trasformò in un plebiscito, anche se l’accordo fu approvato dal 62,2% dei votanti. Se ne avvide lo stesso Marchionne, preoccupato delle ricadute che il voto avrebbe potuto avere sulla gestione dello stabilimento. Gli fece eco l’allora presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che si disse “rammaricata di come i lavoratori non avessero compreso la sfida innovativa di tale accordo”.
Analogo appuntamento referendario vi fu, pochi mesi dopo, il 13 gennaio del 2011, a Mirafiori. Anche qui prevalsero i sì all’accordo, ma con molto meno margine.
Il referendum interessò 5.130 lavoratori delle carrozzerie e i sì vinsero per poco – 54% contro il 46% – con il voto decisivo degli impiegati. In molti casi tra gli operai prevalse il no. In cambio di quell’accordo, che riduceva le pause, modificava i turni e limitava il diritto di sciopero, Marchionne aveva promesso un grande piano di investimenti, piena occupazione, salari più alti e tanti modelli. Uno scenario che, come è noto, non si è mai realizzato.
Il periodo che seguì a questa autentica resa di una parte del sindacato e alla messa al bando dell’altra fu uno dei più neri della storia sindacale repubblicana. Fiat pretese che tutti gli accordi aziendali sottoscritti con il sindacato dopo la guerra fossero cancellati con un tratto di penna. Ma neppure la rinuncia a fondamentali diritti dei lavoratori e delle lavoratrici portò benefici– e non poteva che essere così – all’occupazione al paese.
La città nella città che fu Mirafiori è ora ridotta ad un simulacro di se stessa. Nel suo periodo di massimo sviluppo diede occupazione, nel 1967, a 52.000 lavoratori, saliti a 57.700 nel 1980 con una produzione di 5.000 automobili al giorno, oltre un milione all’anno; attualmente, lo stabilimento è stato quasi completamente disattivato, la produzione è scesa a 85.000 automobili all’anno e gli occupati sono 11.000, solo parzialmente impiegati effettivamente nella fabbrica.
Ed eccoci tornati, dopo questo sintetico excursus sulla storia della Fiat, alle miserie del presente, all’epilogo di un’azienda che ha per tanti anni simboleggiato la natura selvaggiamente predatoria del capitalismo italiano e l’intreccio che l’ha intimamente legata alla politica nostrana e ai suoi governanti.
Oggi, la Fabbrica Italiana Automobili è solo un ricordo dl passato. Al suo posto, tuttavia, con sembianze totalmente mutate, ma pur sempre con a capo un uomo dell’antica famiglia, c’è la Exor N.V., una una società di investimento a capitale variabile, allocata in Olanda, con sede legale ad Amsterdam. Ne è a capo John Philip Jacob Elkann, designato dal nonno Gianni Agnelli come suo successore.
La missione del cinquantenne erede dell’impero Agnelli e della finanziaria appositamente creata consiste nella vendita/svendita di tutto ciò che sa di industria, di produzione materiale di beni, per creare risorse da investire in altre avventure finanziarie, secondo il più usurario mantra capitalista, quello in base al quale non è necessario lavorare per ottenere denaro: il denaro stesso può essere messo a lavorare per produrre altro denaro.
Poi c’è la politica, da tenere al guinzaglio, con la corda corta. E l’informazione.
Il 23 aprile 2020 una società di nuova costituzione, Giano Holding, società per azioni detenuta dalla Exor, ha acquisito la proprietà di GEDI, prima posseduta dalla CIR di Carlo De Benedetti.
Il gruppo editoriale GEDI è editore di “la Repubblica” e “La Stampa”. Fanno parte del Gruppo anche 3 emittenti radiofoniche nazionali (Radio Deejay, Radio Capital, m2o).
Con questa operazione, Elkann detiene il 25% del mercato editoriale nazionale.
Una notizia di qualche interesse: Mark Zuckerberg ha in questi giorni annunciato l’ingresso, unico fra gli europei, di Elkann nel board di Meta, sottolineando le opportunità nel campo dell’intelligenza artificiale e dei social media.
Cosa volete mai che rappresentino, per Elkann, in un simile contesto, gli interessi dell’Italia come paese, tanto meno quelli dei suoi lavoratori. Venderà tutto ciò che resta, al miglior offerente. E’ il capitalismo, bellezza!
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti