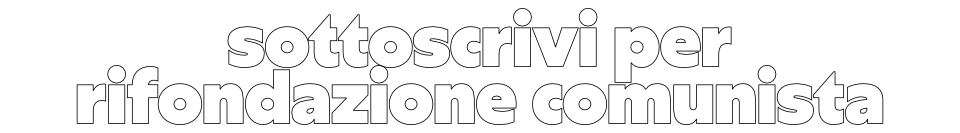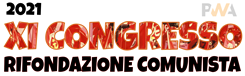Millenovecentosessantotto
Pubblicato il 24 mag 2018
Rino Malinconico
Ho scritto questo carme trentaquattro anni or sono. Nel 1990 lo inserii nella mia prima raccolta di poesie (Noi e io, Editrice Imbarco), e lo ripropongo ora, a cinquant’anni dal ’68, perché mi pare ancora capace di dire qualcosa. È corredato da note esplicative che facilitano la lettura.
MILLENOVECENTOSESSANTOTTO
(ai miei compagni)
I
Poi l’occhio fu segnato dalla vita
e perse di purezza.
Altri lidi emersero dall’onda
e la risacca
quasi in controcanto
fece più lenti i battiti del cuore.
II
Tempo consumato in un respiro
mi premi addosso
e ancora m’affatichi
di fole il capo
e teco
per disperato incanto
mi conduci.
III
Quest’incanto veniva di lontano
oltre il bambù
in terra di levante.
Un uccello vi volava in cerchio
a novantamila lì sopra il terreno.
E c’era un vecchio che spianava i monti
al fin che l’uomo
vincesse la sua storia.
IV
Non s’aspettava che l’assalto al cielo
e nulla di meno.
E si fremette pure ad occidente
per questo gonfiar
del vento di campagna
che dietro si portava e semi e terra
e luccichìo di sole nel mattino.
V
Fu anche tempo di pettine e di nodi.
Troppo spessa era stata la quiete
e lungamente.
Fu rotto dal rimbombo quel silenzio
degli elefanti un’altra volta accorsi
a reclamar l’avorio.
VI
Diede il segnale la pantera nera
e fu versato nell’Ohio il sangue
e a Detroit.
Fu come scatto d’improvvisa rabbia.
Nelle giungle di ferro e di cemento
i bagliori percorsero i quartieri
e le università e le periferie.
VII
Quando giunse alle fabbriche quel fumo
prese paura il mostro-capitale
e la ferocia gl’iniettò lo sguardo.
Nella cintata terra delle Alpi
fece brillare mine nella folla.
Altrove, a Danzica e Stettino
guidava i carri a liberare il passo.
E nel sole del Messico dorato
profanava d’Olimpia il sacro rito.
VIII
Ma agli angoli del mondo
barcollava
il vecchio impero e il nuovo.
E a nulla valse scavare in Indocina
ancora più crateri della luna.
La borghesia sorpresa rimirava
il sacro fuoco riflesso nella Senna
e paventava un nuovo diciassette.
IX
Prematuro timore!
Troppo fondo era il solco
scavato dalla talpa-capitale.
Espugnati tutti erano stati
gli antichi fortilizi proletari
e non più che mondo nuovo
sua veste la Russia ripigliava
qual santa e madre.
X
Ma bastante era alla forza
l’orgoglio giovanile
e l’impazienza
e l’iconoclastia,
onde tuonò l’appassionato verso
all’inclito vate dallo sguardo amaro
plaudente al crudo servo
in Valle Giulia.
XI
«Voi foste fatti
della stessa turpedine dei padri».
Tal detto ingiustamente proferirvi
come di voce della Bibbia austera
che nega il moto al mondo
e lo condanna.
XII
Dimenticasti forse
il travaglio lungo della storia
che rapporti affatica e li rinnova?
Così Natura e Tempo
trasformano le cose
e l’universo senza sforzo vive
continuamente
quando continuamente muore.
XIII
Quei furon cuccioli nutriti
al palmo della mano gentilizia.
Poi conobbero l’osso e la catena
e pur se brusca la carezza prima
non cassarono i calci e la fatica
e tennero a pie’ fermo
il giuramento
del quadrato intorno alla magione
e l’offerta del petto al buon signore.
XIV
Ma venne tempo che al patrizio desco
poco cibo avanzava ed il peggiore
e le carni nutrite ai giorni buoni
la catena nel collo sanguinava.
Quella catena che dianzi ancora
era vessillo di sicura sorta
or si mostra strumento di selvaggio
e ne costringe la sfrenata corsa
lontan dall’ombra del signore antico
da protettrice in Cerbero mutata.
XV
Sopra di sé per vera
allora riconobbe l’ingiustizia.
Ché in tal modo a noi umani
ci è dato di entrare nelle cose:
per gradi, a pezzi
e poi profondamente
sol quando dalla mente esse disvelano
nel solco della vita
e quando il nome
secrèta finalmente l’ansia.
XVI
Si veste dunque
d’esperienza il nome
e Verità centuplica le forze.
S’appalesa così che l’ingiustizia
pasce fin l’ultimo interstizio del reale.
I figli quindi del prisco privilegio
le membra tesero a spezzare il ferro
che nel cuore mordeva
a loro e al mondo.
XVII
Come il calore trepido
irrompe la fanghiglia
che gelida coperse la campagna
e la natura
ritorna aprìca a bere
al sorso della vita
sì che nova e lucente appare agli occhi
così talora avviene
rigenerarsi all’uomo.
XVIII
Non si ristette il pianto
alla perduta aurora
ma l’orizzonte a costoro si dislaga.
Miseria e sfruttamento
ed oppressione
mostrarono la loro umana
carne dolorante.
Sentirono bisogna allora
di un mondo nuovo
e senza privilegio.
XIX
La bramosia struggente
dell’umano
come conquista da lungo tempo attesa
nella pelle vibrava
e nelle teste.
E fu entusiasmo
e fu speranza
e fu noncuranza estrema del periglio.
E fu durezza
e ripida battaglia.
XX
Dall’animale all’uomo
con rabbia s’invocava il brusco salto.
Ma non fu tempo che l’ordine del mondo
venisse rivoltato.
Mille altre ragioni
doveansi forgiare ancora
e ancora mille fili
la forza della storia
premeva avviluppati.
XXI
La massa proletaria
appena era al risveglio
ed esitava a vivere lo scontro.
Fu allor mestieri che cotanta forza
riversa nelle strade
si disperse.
Tramutossi di gioia in sordo dramma
e sùbita disfatta.
XXII
Si visse il cupo brividìo
come freddo ritrarsi di marea.
E chi testardo volle
mancar la riflessione
sull’arco lungo del percorso intero
inutilmente inseguiva la vittoria
nella potenza
del rovente acciaio.
XXIII
Restorno in pochi
a suggere da Gaia
linfa e calor per sostener la pianta
che giovinetta rinsecchìa nell’ombra.
Altri invece scomposero le membra
incontro al cielo
e febbrilmente
diversa e bella forma
nel vuoto altero
stimaron di vedere.
XXIV
All’onde infine
quei tanti rimisero il timone
consegnandosi al Fato per l’approdo.
I vecchi dèi del santo-capitale
al porto indussero la nave
nella inumana terra
degli umani.
XXV
Piagato corpo ai naviganti
bruno del salso sole
e del ventoso
nascondeva in letizia e falsa gioia
quel che dentro si muore
lentamente.
Con implacabil gesto
placenta e pelle si discaglia via
e riparava il petto
di sudicia stanchezza.
XXVI
Eppure accade a volte
di sollevar lo sguardo al sogno audace
e ricercare l’ostinato segno
del tempo e del riscatto.
Rivive nuovamente allor l’antica speme
quando forzando il cerulo orizzonte
ci venga incontro
come d’improvviso
il balenìo di un vortice lontano.
(marzo – dicembre 1984)
(Rino Malinconico, Noi ed io. Millenoventosessantotto e altre poesie, Editrice Imbarco 1990)
NOTE
III Il riferimento è alla Cina, in particolare alla Rivoluzione Culturale (1966 – 1969). Dell’uccello Peng che “volava alto” (il “lì” è una unità di misura cinese) parla Mao Tse-Tung in una sua poesia. Rivolto al passero atterrito che vuole fuggire lontano dal ciclone, il Peng esclama: «Basta con queste idiozie / guarda la terra e il cielo sconvolti da cima a fondo». Come altrove, anche qui Mao sostiene che grandemente positivo è proprio “il disordine sotto il cielo”.
Il vecchio che spianava i monti è anch’essa un’immagine ripresa da Mao. Rielaborando una vecchia favola cinese, egli narrava di un contadino, Yu-Kung, che decide di spianare, armato semplicemente di zappa e con l’aiuto dei soli suoi figli, tre grandi montagne che isolano e imprigionano il villaggio. I suoi compaesani gli danno del pazzo e lo esortano ad abbandonare un’impresa impossibile. Ma per Yu-Kung non è affatto impossibile spianare quelle montagne: «Io morirò ma resteranno i miei figli, moriranno anch’essi ma resteranno i nipoti e, dopo di loro, i figli dei nipoti. Così le generazioni si susseguiranno all’infinito. Le montagne sono alte, ma non possono diventare più alte; e ad ogni colpo di zappa diventano sempre più basse». Nella versione tradizionale gli dèi, commossi dalla tenacia e dalla volontà di quell’uomo semplice, intervenivano e, in men che non si dica, le montagne venivano spianate. Yu-Kung simboleggiava, per Mao, la condizione del Partito comunista cinese, il suo sforzo generoso ed isolato di buttar giù le grandi montagne dell’imperialismo, del feudalesimo e del capitalismo. E nella sua riformulazione gli dèi non sono altro che le masse popolari: se esse si “muoveranno a compassione”, l’«impresa impossibile» della rivoluzione potrà essere realizzata.
IV Ancora una eco di Mao. Il vento di campagna adombra la strategia maoista delle campagne “che accerchiano la città”, ovvero l’idea che la rivoluzione proletaria possa partire dal Terzo mondo per arrivare poi ai paesi del capitalismo avanzato.
Anche i semi, la terra e il sole del mattino riprendono immagini di Mao: «Noi comunisti siano come i semi e il popolo è come la terra. Ovunque andiamo dobbiamo unirci al popolo, mettere radici e fiorire in mezzo al popolo». Ai giovani Mao ricordava: «Il mondo è vostro come è nostro, ma in ultima analisi è vostro. Voi giovani, pieni di vigore e di vita, siete come il sole tra le otto e le nove del mattino…».
V Gli “elefanti che reclamano l’avorio”, ovvero il proletariato che si riappropria di ciò che produce, riecheggiano una immagine adoperata da Jacques Prèvert nel suo testo del 1931 Tentativo di descrizione di un banchetto a Parigi.
VI Qui, come in seguito, non viene rispettata la cronologia degli avvenimenti ma si mettono assieme fatti del 1968, del 1969 e del 1970. Nell’Università di Kent, nell’Ohio, durante un sit-in di protesta contro la guerra del Vietnam furono uccisi quattro studenti dalle fucilate della guardia nazionale. È solo uno dei tanti episodi sanguinosi collegati alla protesta giovanile contro la guerra.
A Memphis, Chicago e altre città americane ci furono, invece, grandi rivolte nere (le “Pantere nere” erano uno dei gruppi politici della sinistra nera ed ebbero un ruolo rilevante nella lotta per l’emancipazione della comunità afro-americana). Le rivolte durarono per tutto il 1968 e furono particolarmente estese dopo l’assassinio di Martin Luther King (4 aprile del 1968).
VII Le “mine nella folla” sono le bombe che tra l’aprile e il dicembre del 1969 inaugurarono in Italia la strategia della tensione e lo stragismo di Stato.
A Danzica e Stettino ci fu, nel 1970, la repressione durissima dei moti operai.
A Città del Messico avvenne il massacro di Piazza delle tre culture. Era il 2 ottobre 1968: centinaia di studenti che protestavano contro il governo furono falciati dalle mitragliatrici dell’esercito. Pochi giorni dopo, come nulla fosse, quello stesso governo inaugurava le Olimpiadi del 1968.
VIII Tra il 1963 e il 1986, in Vietnam, Laos e Cambogia, gli americani hanno scaraventato più tonnellate di bombe di quelle usate nel corso della seconda guerra mondiale da tutti gli eserciti su tutti i fronti. Nel solo Vietnam del Nord si contavano a milioni i crateri causati dai bombardamenti.
Per quanto riguarda la dizione “imperi vecchi e nuovi”, il riferimento è, da un lato, alle grandi potenze occidentali, gli USA in particolare; dall’altro all’Urss. Il sistema imperiale di quest’ultima verrà insidiato dalle vicende cecoslovacche e dalle lotte studentesche in Polonia per tutto l’arco del 1968.
Infine, la rivolta parigina del maggio fu, probabilmente, l’episodio più significativo dell’intero ‘68: operai e studenti sembrarono davvero vicini a prendere il potere.
IX L’accenno alla “Santa madre Russia” di zarista memoria rivela un’idea precisa della storia sovietica. Per l’autore, dopo il 1917 e la fase leninista, il potere proletario non ha avuto in Russia alcuna vigenza reale. Lo stalinismo attuò un originale ed efficace arretramento controrivoluzionario, conservando formalmente i simboli dell’ottobre ma stravolgendone completamente i contenuti. L’idea di fondo è che il comunismo fu sconfitto già nel corso degli anni ‘20, non solo in Europa, in Asia e in America, ma nella stessa Urss. Del resto, il carattere imperialista dell’Urss venne fuori in modo inequivocabile nello stesso 1968, con l’invasione, in agosto, della Cecoslovacchia.
X L’“inclito vate” è Pier Paolo Pasolini. Sul numero 10 di Nuovi Argomenti (aprile 1968) pubblicò un violentissimo attacco agli studenti. Commentando gli scontri di Valle Giulia tra studenti e polizia del primo marzo, Pasolini affermava enfaticamente di stare dalla parte della polizia, il “crudo servo”. La sua motivazione era classista: i poliziotti sono figli di operai e contadini, della povera gente del Sud; gli studenti appartengono invece alle classi privilegiate. Il loro ribellismo era, per Pasolini, strumentale, venato di anticomunismo: «Avete facce di figli di papà / Vi odio come odio i vostri papà. / Siete pavidi, incerti, disperati / (benissimo!) ma sapete anche come essere / prepotenti, ricattatori, sicuri, sfacciati: / prerogative piccolo-borghesi, cari».
XI, XII, XIII, XIV A Pasolini l’autore obietta l’incomprensione dei cambiamenti sociali e la staticità dell’analisi. In sostanza, viene contrapposta alla invettiva pasoliniana la tesi della “proletarizzazione crescente” della piccola borghesia: da massa di manovra del blocco dominante, destinatario di briciole di privilegio e baluardo sociale dell’ordine costituito, il piccolo borghese viene progressivamente trasformato dallo stesso capitalismo, dalla sua crisi (ma ancor di più, ciò che qui non è detto, dalla sua ristrutturazione), in proletario oppresso e sfruttato alla stessa maniera dei proletari tradizionali.
Va comunque ricordato che Pasolini attenuò, negli anni successivi, il suo giudizio polemico.
Cerbero è il cane con tre (o cinquanta) teste della mitologia greca. Era posto a guardia degli inferi, mansueto con chi rientrava e terribile con chi tentava di uscire.
XV, XVI, XVII, XVIII La perdita della condizione di privilegio servile pone le basi sociali per una possibile presa di coscienza anticapitalista da parte degli antichi strati piccolo-borghesi. Il movimento studentesco del 1968 e l’idealità ugualitaria che lo animava hanno rappresentato, per l’autore, la “rivelazione” inequivoca di tale processo storico.
XXI Il ciclo delle lotte aperto dal ‘68 si chiuderà nella seconda metà degli anni settanta. Nonostante la grande fiammata del ’77, la conclusione fu di netta sconfitta, e ciò proprio perché non era maturata fino in fondo la proletarizzazione generalizzata della società. Dalla rapida disgregazione del movimento emergeranno distinte tipologie politico-culturali, abbozzate dall’autore nelle strofe successive.
XXII Alla sconfitta storica del movimento, dovuta alla immaturità della composizione di classe, alcuni tentano illusoriamente di contrapporre la escalation militare. Il riferimento è soprattutto alle Brigate rosse.
XXIII Non mancarono coloro che dalla sconfitta si proposero di trarre riflessioni utili per tenere in vita la pianta giovine della rivoluzione (“suggere da Gaia”: Gaia è la dizione ionica di Gea, antica divinità greca, la Terra-madre nata dal caos), ma restarono in pochi. Di fatto, la gran parte di coloro che mantenevano una visione critica rinunceranno ad un discorso unitario e si rappresenteranno il mondo come un “post-qualcosa”, proclamando superata la stessa necessità di un movimento generale di lotta contro il capitalismo e indicando, invece, obiettivi più particolaristici, spesso venati da pulsioni individualistiche (“diversa e bella forma”).
XXIV, XXV, XXVI Infine quasi tutti si consegneranno (è negli anni ’80, il decennio dell’“edonismo reaganiano”, che fu scritto il carme) all’avversario, alla borghesia nuovamente rampante, che li riaccoglierà nell’ambito dell’ordine costituito. È il “riflusso”: coloro che pure avevano sognato il “mondo nuovo”, accettano amaramente le regole e le condizioni del capitalismo. E però non riescono del tutto a “mutar pelle”, poiché la speranza umana di un vivere più felice per tutti continuerà a tentarli, ponendoli all’ascolto di un nuovo, possibile vortice della storia.
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti