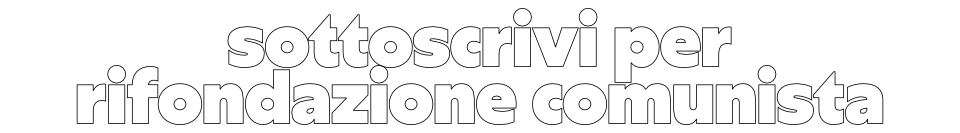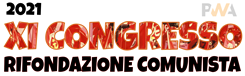L’armonia delle tenebre
Pubblicato il 2 apr 2013
di Alberto Burgio -
Buon esempio della pervasività del potere nazista, le vicende occorse al mondo della musica nei dodici anni di vita del «Reich millenario» sono da alcuni anni oggetto di attenzione da parte della storiografia e anche – per ciò che riguarda la produzione dei musicisti finiti nei Lager – di una musicologia meritoriamente impegnata nel recupero e nella diffusione di un tesoro (circa quattromila partiture) ancora in larga parte misconosciuto (si pensi all’attività svolta da Musikstrasse nell’ambito del progetto «Musica concentrazionari»).
Quella ora offerta da Nicola Montenz è una sintesi documentata e agevole (salvo la deplorevole assenza di un indice dei nomi) di quanto, già a partire dai tardi anni Venti, accadde a compositori, musicologi, direttori e interpreti più o meno celebri: della sorte, cioè, toccata per un verso ai musicisti ebrei, particolarmente numerosi tra i grandi artisti dell’epoca, esclusi dalle orchestre e dalle rappresentazioni, marchiati come veicoli di «arte degenerata» e costretti all’esilio o deportati nei campi di sterminio; e, per l’altro, agli «ariani» che ebbero modo di intraprendere brillanti carriere nella misura in cui accettarono di porsi al servizio del regime per nobilitarne l’immagine in patria e sul piano internazionale.
Se la ricostruzione non aggiunge nulla al noto, ha nondimeno il pregio di ripercorrere con precisione ed equilibrio una storia emblematica, non senza soffermarsi sui problemi rilevanti, anche sul terreno morale, che già campeggiano sullo sfondo delle pagine del Doktor Faustus e delle stesse Considerazioni manniane. E ha per ciò stesso il merito di porre in evidenza la fatale ambivalenza della musica quale forma espressiva aperta al dialogo con la violenza e con l’orrore.
Se il destino tragico dei perseguitati (spiccano le figure di Bruno Walter e Otto Klemperer, di Schönberg, Weill e Krenek, e, tra i deportati a Birkenau, quella, affascinante e misteriosa, della nipote di Mahler, Alma Rosé) mostra l’abisso di feroce demenza sempre immanente all’odio razzista, le multiformi esperienze di quanti scelsero di «allinearsi» alla «politica culturale» del regime (e financo alle pratiche delatorie da esso prescritte) documentano appieno il servile opportunismo di chi decise di ignorarne i crimini pur di raggiungere fama e ricchezza (si pensi ad artisti del calibro di Orff, Karajan e Böhm, celebrati anche nel dopoguerra), la consapevole complicità dei musicisti conquistati all’ideologia nazista (come Hans Pfitzner, Elly Ney e Wilhelm Backhaus) o la sciagurata illusione (coltivata dagli «apolitici» Strauss e Furtwängler) di preservare incontaminato il proprio universo di cultura e arte nel bel mezzo di una demoniaca orgia di sangue.
Il fatto che vi fosse anche chi rifiutava di prestarsi al gioco (come, tra altri, il violinista Josef Szigeti o il sovrintendente Gustav Hartung, quando Goebbels chiese al primo di sostituire l’«ebreo Hubermann» e alcuni membri del Parlamento dell’Assia ingiunsero al secondo di cacciare dal teatro di Darmstadt gli ebrei e gli «inaffidabili») dimostra una volta di più che il paradigma del «terrore totalitario» non basta per capire quanto avvenne nella Germania di Hitler, e rischia di funzionare come un alibi per quanti acconsentirono e parteciparono.
Nicola Montenz
L’armonia delle tenebre
Musica e politica nella Germania nazista
Archinto (2012), 332 pp.
€ 16,00
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti