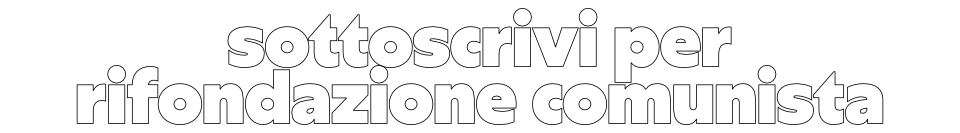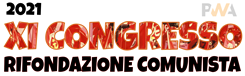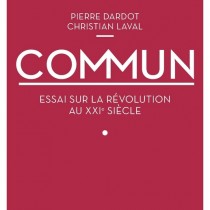
Beni comuni e comunismo, il nuovo libro di Dardot e Laval
Pubblicato il 5 giu 2015
di Roberto Esposito
«AVVISO ai non comunisti: tutto è comune, perfino Dio». Questo sfolgorante aforisma di Baudelaire campeggia come esergo all’inizio dell’ampia ricerca che Pierre Dardot e Christian Laval hanno dedicato alla questione dei beni comuni con il titolo Del comune o della Rivoluzione nel XXI secolo (DeriveApprodi, a cura di A. Ciervo, L. Coccoli e F. Zappino, con una introduzione di Stefano Rodotà). Sul tema da qualche tempo fioriscono saggi filosofici, economici, giuridici — l’ultimo dei quali di Ugo Mattei, col vigoroso titolo Il benicomunismo e i suoi nemici , appena pubblicato da Einaudi. A motivare questa improvvisa ondata di interesse per l’argomento — che ha portato qualche anno fa alla istituzione della Commissione Rodotà e alla promozione del referendum sulla sottrazione dell’acqua al profitto privato — è la difficoltà crescente di immaginare modelli alternativi al regime neoliberista che si è imposto in tutte le democrazie occidentali.
Tutto è comune, anche Dio
di Roberto Ciccarelli
Del comune, o per farla finita con i beni comuni. Potrebbe essere questo il titolo alternativo alla nuova monumentale opera di Pierre Dardot e Christian Laval: Del comune o della rivoluzione nel XXI secolo (DeriveApprodi, 2015). La polemica non è solo teorica, ma politica. Non si attacca la stagione dei movimenti sociali a partire dal referendum sull’acqua del 2011, né si liquidano i beni comuni per riaffermare il ruolo dello Stato o del mercato.
Dardot e Laval propongono una teoria dell’istituzione, del diritto all’uso e di una prassi socio-politica per liberare il principio del “Comune” dalla reificazione giuridica di “bene”, vale a dire dalla sua principale contraddizione. Lo Stato e il mercato non sono gli angelici portatori di un verbo impersonale al servizio di tutti, ma i vettori della normalizzazione o della distruzione dell’agire comune.
Nella prefazione alla traduzione italiana, Stefano Rodotà ricorda che i “beni comuni” rappresentano una nuova tassonomia dei beni il cui scopo è esprimere la personalità di ciascuno e permettere l’esercizio dei diritti fondamentali. I “beni comuni” rappresentano inoltre una dislocazione del diritto dall’ambito proprietario e mercantile a quello dell’uso collettivo. Legittimamente, scrivono Dardot e Laval all’altro capo del volume, questa teoria vorrebbe liberare ciò che comune agli uomini dal comando dello Stato e dalla proprietà privata. Il suo problema è che continua a usare la categoria giuridica di “bene comune” (o di “beni comuni”) che ha logicamente bisogno di uno Stato.
Uno spazio per il comune
Qual è allora lo spazio per il “comune” (e per i beni comuni)? Per Dardot e Laval è la prassi collettiva. Bisogna ripensare il “comune” al di fuori del “bene” e sviluppare il concetto di “uso comune” incarnandolo nell’agire in concerto, un’espressione di Hannah Arendt tradotta in “co-attività” e “co-decisione”. Non si tratta di rifiutare lo Stato, né di collocarsi al di fuori del diritto, ma vedere entrambi come entità e strumenti di una nuova teoria del governo e dell’istituzione. Quella ispirata dal filosofo (e molto altro) greco-francese Cornelius Castoriadis che la definì “prassi istituente”.
Alla base della categoria giuridica di “beni comuni” esiste una prassi che ingloba sia il fare sia la poiesis, cioè l’agire che non ha solo l’obiettivo di fabbricare un oggetto, ma lo sviluppo delle facoltà del soggetto. Una prassi è “istituente” (e non “istituzionale né “istituzionalizzante”), quando crea nuove istituzioni e non si limita a perfezionare il funzionamento di quelle esistenti in una costituzione data. È questo il senso della “rivoluzione” per il nostro secolo indicata nel sottotitolo di questo volume.
In principio è il comune
Dardot e Laval considerano il “comune” un “principio”, e non una cosa, una sostanza, o una qualità propria. “Il principio – scrivono – viene prima e fonda tutto il resto”. “Ordina, comanda, regge l’attività politica”. È una definizione che si presta a diverse interpretazioni. Il “comune” è il prodotto dell’agire di chi partecipa a un’attività comune, ma anche il principio che giustifica tale attività. Cosa giustifica l’idea per cui il principio sia sempre, e comunque, il risultato di un agire comune tra gli uomini? I sostenitori della sovranità o della proprietà privata potrebbero essere d’accordo, ponendo i loro valori al centro della stessa teoria.
L’unica, possibile, giustificazione della verità ontologica affermata da Dardot e Laval (“In principio è il Comune, il Comune è il principio di tutte le cose”) è politica. Il comune è un principio politico. Senza la storia raccontata in questo libro – il socialismo auto-gestionario e associativo, il comunismo dei consigli o anche le teorie dell’insurrezione e del potere costituente – la tesi del volume sarebbe infondata. E, tra l’altro, soggetta a influenze teologiche.
Invece, considerando le esperienze storiche e, in generale, dell’irruzione della politica delle masse sulla scena dell’Otto-Novecento, oggi si può comprendere che il principio evocato dagli autori è, più propriamente, una potenza. E, come tale, condizionata alla soggettività che la esprime e alla storia politica di cui è il segno.
Ritorno al mutualismo
Del Comune spiega come si costruisce una forza sociale e politica, situata nel tempo e nello spazio, e non in funzione di un mero principio ontologico. Questo, in fondo, è il suo interesse: indicare un’attualità pratica nel presente, diretta alla costruzione di una forza collettiva. Gli strumenti per realizzare questa “politica del comune” sono tre: il mutualismo, la cooperazione, il federalismo.
Concetti con una lunga storia, esposta da Dardot e Laval in maniera suggestiva. Chi oggi parla di “mutualismo” a proposito del coworking, delle pratiche di mutuo-aiuto, di quelle sindacali o nell’ambito della cosiddetta “innovazione sociale”, troverà in questo libro l’origine di una storia rimossa da quasi un secolo. In termini filosofici, il mutualismo è una pratica derivata da “mutuum”. A sua volta, questo concetto è il derivato di “munus”, cioè un “dono che obbliga a uno scambio”. L’aggettivo derivato è “communis” – il “comune”. Indica la condizione di chi ha in comune i “munera”, cioè i doni da scambiarsi.
Nella storia del movimento operaio, il “comune” è stato prodotto da quella che Dardot e Laval chiamano la “co-attività” tra gli individui associati sul lavoro e nella società, non da una comunità “popolare”, “sangue e suolo” oppure “nazionale”. Le pratiche del mutualismo sono solidali, economiche, socio-sanitarie, finanziarie, politiche e sono basate sull’auto-organizzazione, non sulla delega o sulla rappresentanza.
Questo scenario è possibile solo attraverso la creazione di federazioni su base sociale e professionale, ma anche politica e istituzionale, tanto su scala locale quanto su quella globale. Fare politica oggi significa federare una pluralità tendenzialmente infinita di pratiche. Un’attività che può diventare molto complessa. All’inizio ci sono tuttavia le unità di base – le “comuni” politiche, così le definiscono Dardot e Laval, basate sull’auto-governo politico, sociale o lavorativo che si sviluppa sui territori. Queste “comuni” formano coalizioni a livello nazionale e, a livello globale, mostrano un’idea di governo basata su una nuova razionalità politica, quella dell’auto-governo.
Un’alternativa al nuovo feudalesimo
La politica del comune è ispirata a un’idea di federalismo non sussidiario, ma comunista. Questo comunismo federalista risponde a una tradizione sconosciuta oggi, e negletta nella storia dello stesso movimento operaio. È stata formulata inizialmente da Proudhon nel 1840, ha contagiato Marx quando scriveva della Comune di Parigi nel 1871. Del tutto rimossa dalla storia del comunismo sovietico, e dalle divergenti vicende del comunismo e della socialdemocrazia europea, questa peculiare idea di comunismo oggi circola sotterraneamente.
Dardot e Laval la riscoprono come possibile alternativa al sistema del governo capitalistico e alle attuali tendenze alla rifeudalizzazione delle sovranità nazionali o all’odio del populismo xenofobo. La loro impresa genealogica la colloca correttamente nel diritto romano, rinviando all’antico senso del “municipium”. Questa tradizione ha avuto un singolare sviluppo nella tradizione del federalismo europeo e, in particolare, nel municipalismo repubblicano e civile italiano, come abbiamo ricostruito nel Quinto stato, un libro che ha singolari assonanze con quello di Dardot e Laval. C’è tuttavia una differenza sostanziale non colta dagli autori francesi: il diritto romano imponeva a tutti l’obbligo dei tributi e del servizio militare. Nel 1858 Carlo Cattaneo invece scriveva che il mutualismo emerge come il senso del diritto e della dignità civile.
Dal punto di vista storico, le pratiche mutualistiche sono state applicate nel municipalismo italiano tra il X e il XII secolo. Fu questo il primo incubatore della borghesia moderna. In seguito furono applicate all’origine del movimento operaio. Oggi Del Comune propone la loro applicazione nella società del lavoro indipendente (precari, autonomi, inoccupati) per favorire la crescita di un processo di costituzione civile antagonista alla storia, culturale e costituzionale, dello Stato-Nazione.
L’obiettivo è creare una cittadinanza non statale e non nazionale, ma insorgente. L’attenzione del libro è rivolta alla creazione di cittadini politicamente capaci di inventare istituzioni che permettano di essere co-produttori coscienti del comune, non solo consumatori di servizi o di merci. L’operazione è ardita, e mai come oggi l’attitudine alla cooperazione viene negata alla radice. E, tuttavia, queste sono le coordinate condivise dalla cultura globale dei “beni comuni”.
La strada in salita
Quello di Dardot e Laval è un programma filosofico ambizioso, ispirato alla vena socialista eretica e al costituzionalismo illuminista radicale che presenta un’ipotesi di comunismo per il XXI secolo. In questa cornice, lo Stato non scompare, ma diventa l’estensione di un continuum istituzionale che lo eccede dall’alto e dal basso.
Il suo principio-base è la comune, non la comunità. L’auto-governo, non la sovranità popolare. L’attività, il lavoro, la professione, l’interesse culturale, civico ed economico per garantire il quale gli estranei si uniscono per condividere risorse, saperi, tempo libero e possibilità. La reciprocità riguarda potenzialmente tutti gli aspetti della vita individuale e associata.
È una strada in salita. Viviamo in tempi non rivoluzionari. E, se una rivoluzione esiste, è quella neoliberista per la quale non esiste altra realtà che quella in cui viviamo. Nell’orizzonte di una vita umana, ovunque è negata la praticabilità di un’autonomia. Il lavoro non è il luogo della cooperazione, ma dell’auto-sfruttamento a titolo gratuito. Il futuro è un incubo, senza pensione, né reddito.
Proprio in questo abisso, al culmine della disperazione, c’è una vita che brulica e dimostra l’esistenza di un’alternativa nelle pratiche quotidiane. Quelle incarnate nei corpi che si spingono contro quell’orizzonte. Al crepuscolo, torniamo a leggere il verso di Baudelaire, citato all’inizio del libro: “Avviso ai non comunisti: tutto è comune, anche Dio”.
fonte: Alfabeta2
Sostieni il Partito con una
Appuntamenti