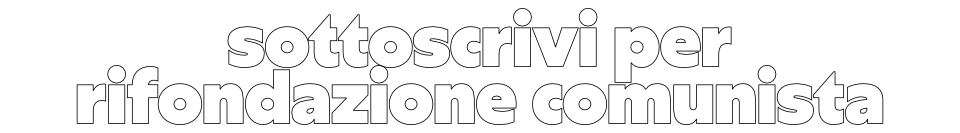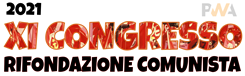La coscienza dell’Europa. Perché non si ribella alla subordinazione agli USA e al riarmo?
di Laura Tussi *
Una subordinazione che soffoca l’autonomia
Per decenni, l’Europa ha cercato di affermare la propria autonomia strategica, economica e diplomatica. Eppure, di fronte alle recenti crisi globali, questa aspirazione sembra essersi dissolta. Le decisioni in materia di politica estera, le sanzioni economiche e gli schieramenti militari appaiono sempre più in sintonia con gli interessi statunitensi, spesso a scapito di un’analisi indipendente e di una ricerca di soluzioni diplomatiche che potrebbero servire meglio gli interessi del continente.
Questa subordinazione non è solo una questione di geostrategia, ma una profonda crisi di identità. L’Europa ha rinunciato a essere un attore pacificatore e un ponte tra le diverse potenze mondiali, preferendo il ruolo di alleato subalterno. Questo asservimento non fa che indebolire la sua posizione, rendendola più vulnerabile agli effetti collaterali di conflitti non suoi e alienandola dalla sua vocazione originaria.
La pericolosa illusione del riarmo
Il secondo grande tradimento della coscienza europea è la frenetica corsa al riarmo. I bilanci della difesa in tutto il continente stanno lievitando, deviando risorse preziose che potrebbero essere investite in sanità, istruzione, protezione sociale e lotta contro la crisi climatica. La retorica del “bisogno di difendersi” sta giustificando un’espansione militare che alimenta l’industria bellica e spinge il mondo verso una nuova e pericolosa era di militarizzazione.
Il riarmo, lungi dall’essere una garanzia di sicurezza, non fa che accrescere le tensioni e perpetuare un ciclo di paura e sospetto. Un’Europa armata non è un’Europa più sicura, ma un continente che si allontana sempre di più dal suo ruolo storico di promotore del dialogo e del multilateralismo. Si sta abbracciando una visione del mondo basata sulla forza, dimenticando che la pace non si costruisce con le armi, ma con la fiducia reciproca e la cooperazione.
Un richiamo alla coscienza perduta
La coscienza europea, se non è del tutto scomparsa, è certamente silenziata. I movimenti pacifisti e le voci che chiedono un’Europa veramente indipendente e nonviolenta sono spesso emarginati nel dibattito pubblico. Eppure, la storia ci insegna che la vera forza di un’Europa unita risiede nella sua capacità di essere un faro di pace, un modello di convivenza civile e un punto di riferimento per la diplomazia globale.
È tempo che l’Europa si interroghi profondamente sul proprio percorso. È tempo di ribellarsi alla subordinazione e di disarmare gli animi, prima ancora degli eserciti. L’alternativa è un futuro in cui l’Europa non sarà altro che un’appendice militarizzata di una superpotenza, tradendo per sempre la sua missione storica e la memoria di milioni di persone che sono morte affinché potesse nascere un continente di pace.
La storia maestra di vita ripudiata
La storia costituisce la forma di coscienza attraverso la quale l’Europa interpreta se stessa. Questo non vale per tutte le culture. Per esempio le culture asiatiche e la sapienza cinese pensano il proprio passato non attraverso le categorie mentali europee, ma tramite un altro tipo di saggezza.
L’Europa si riconosce attraverso la propria storia e la storiografia, il modo in cui noi europei abbiamo preso coscienza di noi stessi, che conduce ad una prima interessante conclusione: cosa significa che l’Europa prende coscienza di sé tramite la storia? Vale a dire che l’Europa non si dà un destino precostituito, non è un continente terraneo come l’Asia, dove la determinatezza delle coordinate fisiche lascia individuare piuttosto un destino precostituito rispetto ad un divenire in fieri.
L’Europa si interpreta attraverso un progressivo allontanamento dalle radici, dalle matrici storiche e non per un destino prestabilito, ma è in continuo divenire, in metamorfosi storiche, in cambiamenti epocali: non sta, non è, ma diviene. Questo il primo nucleo di riflessione sull’importanza che il principio della storicità ha per l’Europa, la cui evoluzione storica risulta così importante che costituisce il criterio per cui il nostro continente conosce e parla di se stesso.
La scienza storiografica compie un continuo ripensamento della propria dimensione. Croce sosteneva che la storia è sempre contemporanea e nasce da una passione presente.
Qual è il punto di equilibrio fra questa passione da cui nasce l’evoluzione degli eventi e la sua scientificità? La filosofia: continua capacità di rimettere in discussione, in interazione il presente ed il passato in un punto di principio, quando si vede che l’Europa nella Storia proietta il continuo riflesso del proprio divenire e della propria presa di coscienza: un divenire di coscienze, di memorie, di eventi che scorrono nel fluire incessante dei tempi, dall’idea del divenire, che interessa la Realtà costituente e costituita dell’Europa, scaturisce il grande principio di libertà, valore in cui si identifica sommamente il nostro continente.
Il principio di libertà ha unificato la coscienza che gli Europei hanno di se stessi
La coscienza europea si formava, già in tempi antichissimi, da Erodoto, Aristotele e nell’epoca moderna da Machiavelli, Voltaire, Hegel, Croce, intorno al contrasto con la non libertà, perché alle origini l’Europa è contro l’Asia, la libertà contro il dispotismo, la cittadinanza contro la servitù. Hegel sosteneva che la caratteristica peculiare dell’Europa rispetto all’Asia terranea, caratterizzata dalla dimensione della terra, si connotava peculiarmente per la presenza prevalente dell’elemento acqua, il mare, origine, matrice, madre del tutto, che richiama, anche mitologicamente, l’idea di rischio, di viaggio: il divenire, la libertà, la storicità. Intorno a questi concetti si stringeva la consapevolezza che l’Europa prende di se stessa in un’identità peculiare.
Europa è fondamentalmente un’idea, uno stato d’animo, una sensibilità
Memoria e storia europea richiamano il nodo difficile di problemi in una drammaticità di tensioni senza pari,
poiché mettere al centro della propria coscienza l’idea di libertà di un’Europa i cui confini continuamente mutavano in geometrie e geografie variabili dove in un continuo trauma cambiavano, dilatandosi e restringendosi, i confini dei territori.
L’Europa è fondamentalmente un’idea, uno stato d’animo, una sensibilità, un modo di essere, non un fatto geograficamente ed assolutamente determinato.
Queste riflessioni mettono in moto categorie di storia, filosofia, politica e filosofia della storia, ma si concentrano su un punto aspro: il concetto di libertà che apre un abisso liberatorio da dati immediati ed imminenti, un quid in movimento, di rischio, libertà, avventura, in un crogiolo di etnie, intelligenze, culture, appunto.
La forza del principio “libertà” in cui Europa ha riconosciuto se stessa ha sempre rappresentato un principio di grande tensione e lotta per la conquista della libertà, al punto che filosofi da Croce a Husserl sostengono che la Storia d’Europa è conflitto tra le filosofie e se non ci fosse stata disputa, tensione, lotta non ci sarebbe stata unità. Nella prima metà del 1900 è scaturita dalla cultura una vera diatriba tra diverse filosofie della vita, della storia, della politica, diversi modi di pensare l’organizzazione del mondo. In Europa sono convissuti drammaticamente degli opposti, in “enantiodromie” dominanti, conflitti radicali, dalla rivoluzione inglese alla rivoluzione francese: il continente dei diritti umani fondamentali da rivendicare con la ragione, la terra della resistenza antifascista attraverso i diritti umani, le rivendicazioni sociali al potere.
La storia da “Auschwitz” a tutto il dramma della Shoah, tutto nasce dalle viscere dell’Europa, a partire dalla dittatura fascista.
Tutto il flusso dei drammatici e tragici eventi del secolo provengono dalle viscere dell’Europa. Si potrebbero persino ricostruire coordinate culturali per osservare dove ha preso corpo una così tragica idea dell’interpretazione, dell’evoluzione, della progressione della storia da dover procedere attraverso l’abolizione di un intero mondo culturale, religioso, ideologico, come il tessuto ebraico, e come l’intera opposizione, la presa di coscienza, in generale, contrapposta all’ideologia del sistema dittatoriale dominante. Queste sono le dimensioni in cui si è mossa la storia nei caratteri primitivi di morte e tensione. Un continente che affida il proprio divenire al principio di libertà non è libero dal male, in quanto carico di tentazioni, tensioni, conflitti, lotte, guerriglie, rivendicazioni, aspirazioni, ideali.
La liberazione del principio di cittadinanza: questo il tema grandioso della storia dell’Europa moderna, connesso al principio dell’appartenenza.
Heidegger è uno dei filosofi, grandi interpreti del nostro continente nel secolo breve, il ‘900, durante il discorso che tenne all’Università di Friburgo, nello stesso anno dell’ascesa al potere di Hitler nel 1933. Proferì una disquisizione rivolta ai giovani tedeschi, richiamando la forza dell’appartenenza alla terra, alla materialità che sfuggiva ai confini dell’universalismo della cittadinanza liberale del cosmopolitismo. Quindi due concetti e principi si sono contrapposti al centro, all’interno delle viscere di un’Europa in fermento, in ebollizione ideologica.
Quale prospettiva storica oggi?
Occorre mantenere fortissima la coscienza della storicità del nostro continente non facile perché oggi la memoria è scardinata dalla dimensione obiettiva delle società.
E’ difficile attualmente il rapporto tra società e memoria, per lo scollamento tra generazioni, risultato di tale discontinuità. Rispetto al globalismo che il continente ha sempre interpretato in funzione eurocentrica, da quando il globo è diventato tale, in seguito l’Europa ha vissuto la piena crisi per la messa in discussione della funzione di una propria centralità di coscienza storica.
L’Europa, attualmente, sta tentando una risposta al globalismo unendosi con tutte le enormi difficoltà e grandiosità di questo processo storico inevitabile. Questo secolo è stato testimone di guerre catastrofiche nell’annientamento di decine di milioni di vite; dal 1950 muta, cambia lo scenario. Con una profondità nella storia europea di un percorso avviato ad interpretare risposte ai processi di globalizzazione che potrebbero spingere verso frammentazioni ancora più radicali.
Invece l’Europa ha deciso di unirsi per rispondere al globalismo, e non solo dal punto di vista del mercato e della moneta unica, ma probabilmente, come istituzioni politiche per cui i processi che sono in corso si avvieranno, uscendo da arroccati provincialismi, ottusi settorialismi o scomodi localismi. Ma con la tragica politica del riarmo a oltranza.
I fantasmi dell’Europa si ripresentano continuamente esprimendosi nell’intolleranza, nel disconoscimento delle diversità, della non volontà di riconoscere e rispettare l’altro, il diverso: i fantasmi della Storia sono profondamente radicati nella mentalità comune, nella cultura nel ritorno irrazionale ai subnazionalismi, nei progetti assurdi ed obsoleti di localismi senza principio che rientrano nelle ataviche incongruenze della famosa dialettica storica, dove comunque la complessità, la ricchezza, il valore universale dell’idea di Storia d’Europa deve ancora accordare fiducia al genere umano. Dal Manifesto di Ventotene contro le politiche belliciste e militaresche del riarmo europeo.
*da “Il faro di Roma”